
Nella tarda antichità si assiste alla coesistenza da un lato della religio ufficiale romana, e dall’altra al proliferare di nuove forme religiose, soprattutto di provenienza orientale.
Molti dei culti della religione ufficiale si mantengono, altri cadono in disuso nel III secolo d.C., per poi essere rivivificati nella metà del secolo successivo dall’aristocrazia senatoria nell’ambito di un processo di restaurazione culturale e religiosa.
Già con la dinastia dei Severi e l’arrivo di nuovi imperatori non occidentali, nuove divinità vengono portate a Roma, che continuano però a affiancare culti più radicati e antichi, come quello di Giove Capitolino (molto amato da Diocleziano e dalla tetrarchia), o quella della Dea Roma. La stessa Urbe, ancora nel corso del IV secolo, viene definita “tempium mundi totius”.
Caracalla fa erigere entro i confini cittadini un tempio dedicato a Serapide, Elagabalo introduce il culto del dio solare della sua città natale, Emesa, mentre Aureliano quello del Sol Invictus.

Il bassorilievo rappresenta l’origine del mondo e fu forse donato da un sacerdote ad un mitreo, come indica l’iscrizione riferita ad un certo Felix, citato in qualità di Pater, il più alto grado nel corpo sacerdotale mitriaco. Non è invece chiaro il ruolo di Euphrosyne, una donna il cui nome è inciso sul lato destro della lastra.
Ph. Martina Cammerata Photography
Dall’ultimo decennio del IV secolo d.C., avviene una rottura sostanziale e formale del legame che da sempre univa lo Stato alla religio. Ciò è ben esplicitato dalle decisioni prese da alcuni sovrani cristiani: il rifiuto dell’imperatore Graziano di assumere la carica di pontifex maximus, il taglio di fondi statali al culto di antiche divinità o a collegi sacerdotali, e infine la rimozione dell’Altare della Vittoria dalla sede del Senato da parte di Teodosio. Un atto, questo, fortemente simbolico. Tutte decisioni atte a sottrare linfa vitale alla vecchia religione, non solo attraverso l’emanazione di editti o leggi.
Resta però forte il culto della persona dell’imperatore. Tale culto imperiale non può essere relegato negli schemi del disegno politico di legittimazione del potere, ma pur nel mutare delle forme, delle circostanze, e delle intenzioni dei personaggi oggetto di culto e dei loro seguaci, esso mantiene una forte valenza simbolica e religiosa, che cambia a seconda delle province dell’impero. A Roma, ad esempio, difficilmente viene riconosciuta la divinità o il carattere divino dell’imperatore ancora in vita, pur tuttavia esaltandone le qualità, e celebrando la sua apoteosi post mortem almeno fino al V secolo.
Nei momenti di profonda crisi, inoltre, come quelli che si verificano tra il IV e il V secolo, si assiste da parte della popolazione alla ripresa di antiche discipline pagane di etrusca memoria, che si pensava avessero addirittura salvato la città di Narni da Alarico.
La crisi delle espressioni religiose ufficiali
La crisi delle espressioni di culto ufficiale, che per secoli avevano favorito la legittimazione del potere vigente, favorisce la diffusione di nuove religioni “della crisi” o alternative. Queste sono per la maggior parte culti di derivazione orientale, di natura misterico-iniziatica, che giungono da est a ovest attraverso le rotte commerciali o i viaggi di intellettuali e mercanti. Man mano che si avvicinano all’Occidente, si arricchiscono di simboli e contenuti sacri nuovi.
Questi culti riscuotono subito un grande successo nella popolazione, perché non sono legati a una determinata zona o città, né tantomeno a una specifica comunità, ma si rivolgono al singolo come individuo. Sono religioni che vanno a sostituire i legami parentali e affettivi di base con forme spirituali di parentela, che permettono agli adepti di conservare la propria identità pur nel continuo peregrinare.
I culti orientali rispondono e vanno incontro a esigenze individuali, desideri di definizione del singolo e bisogni spirituali.

Il fatto di possedere un carattere iniziatico contribuisce a creare un senso di coesione nella comunità dei credenti: in un contesto di totale riservatezza si contempla un’iniziazione individuale che abilita il singolo a partecipare all’interno del complesso rituale, dove l’evocazione simpatica (sympatheia) delle vicende mitiche lo introduce in un nuovo status, caratterizzato da una familiarità nuova con gli dèi. Tale vicinanza gli offre prospettive di una vita beata dopo la morte.
La maggior parte di queste divinità orientali, infatti, portano messaggi salvifici e condividono un destino di morte e resurrezione.
Altra caratteristica di successo è data dal fatto che queste religioni non necessitano di alcuna conversione né tantomeno di un’esclusività.
Tra i culti, quelli di maggiore rilevanza sono sicuramente quelli di Iside, Cibele e Mitra.
Alla figura della dea Iside dedicai tempo fa, proprio qui sul sito, un approfondimento, quindi mi limiterò a dire che la devozione a questa divinità è facilitata anche dal fatto che al suo interno vi sono riconosciuti tratti, caratteristiche e nomi di altre dee preesistenti.
Leggi anche I Romani e il culto di Iside

Ph. Martina Cammerata Photography
Il culto di Cibele giunge a Roma dall’Asia Minore tra il 205 ed il 204 a.C., ma tra il II ed il IV secolo d.C. si arricchisce di nuovi aspetti mistico-rituali e personaggi come quello di Attis, con prospettive di salvezza e la compresenza di riti metroachi e taurobolii.
Quanto alla religione mitraica, di origine iranica, si diffonde in Occidente a partire dal I secolo d.C. e fino a tutto il IV secolo, soprattutto presso località portuali e in zone fortemente militarizzate, come quelle dei limes renano e danubiano. Essendo un culto rivolto esclusivamente al sesso maschile, prende piede tra le fila dell’esercito, divenendo sinonimo di lealtà e fedeltà. In quest’ottica, nel 307 d.C. il Sol Invictus Mithra (sincretismo tra le due divinità Mitra e Sol Invictus) viene eletto come protettore dell’Imperium dai tetrarchi a Carnuntum.
Leggi anche Sol Invictus

Nella struttura misterica della prassi culturale mitraica, è fondamentale l’esperienza mistica. Essa si concretizza col superamento di sette gradi, ciascuno collegato ad una divinità planetaria.
Accanto alla figura di Mitra, nella tarda antichità fa la sua comparsa quella di un’altra divinità, Aion, dio del tempo e dell’eternità. Questo è raffigurato come un uomo dalla testa leonina, avvolto nelle possenti spire di un serpente. Sul corpo spesso compaiono i segni dello Zodiaco (Ariete, Bilancia, Capricorno, Cancro: i quattro segni corrispondono ai due solstizi e ai due equinozi), poiché il tempo è il signore di tutte le cose, che si svolgono secondo il cammino scritto negli astri, nei movimenti del cielo. Proprio lo Zodiaco mette Aion in relazione ad un’altra divinità, Fanes, il tempo cosmico.
Un altro caso del tutto particolare è costituito dai misteri eleusini, che vengono praticati nella città di Atene almeno fino alla fine del IV secolo, periodo in cui il tempio di Eleusi viene distrutto da Alarico (396 d.C.). A differenza degli altri culti che “migrano” verso Occidente, ad Atene il culto misterico eleusino rimane ben radicato nel substrato cittadino, tanto da attirare pagani verso la città greca.
Tanta è l’importanza di certi riti dei culti misterici pagani che, nel 364, lo stesso imperatore Valentiniano I abolisce i sacrifici notturni, ad eccezione dei misteri che garantiscono la salvezza del genere umano.
Una forma di cristianesimo: lo gnosticismo
Lo gnosticismo nasce nel II secolo d.C. come risposta ad un problema, quello del male, avvertito (forse per la prima volta nella storia dell’umanità) in tutto il suo spessore ontologico e il suo orrore metafisico.
Ciò però non deve indurre a pensare che questo sia un fenomeno caratterizzato dall’anticosmismo, ossia da un atteggiamento ostile o disinteressato nei confronti del mondo materiale, ma al contrario nella loro teosofia vi è anche un interesse indirizzato verso la realtà effettiva, di cui si cerca di comprendere e penetrare col pensiero le strutture profonde. La loro attenzione in tal senso è rivolta alle problematiche di tipo sociale, dato che nella loro visione il mondo materiale appare corrotto (governato dalla malvagità di divinità minori o demoni, detti arconti), alla comprensione delle cause dei fenomeni naturali e all’astrologia, dato che si ritiene che gli astri influenzino la vita dell’uomo.
Il compito dello gnostico è quello di riconoscere le cause e gli effetti provocati dall’influsso di stelle e pianeti, per non restare passivo al loro arbitrio.
Lo gnosticismo può essere quindi inteso come una religione del disagio e dell’inquietudine: lo gnostico non si sente a proprio agio in questo mondo, che ai suoi occhi appare difettato, maligno, sbagliato, ingiusto. Se da una parte c’è un rifiuto di questo mondo, dall’altra però esso va conosciuto.
Un’altra tematica cara agli gnostici è quella ontologica riguardo all’entità essenziale dell’essere umano, che è percepita come una situazione di scissione e di contraddizione, giocata su uno scambio reciproco e continuo tra opposti. Il mondo appare altro rispetto all’identità dello gnostico, e a sua volta l’identità vera è altro rispetto al mondo. Lo gnostico si muove quindi tra il sé e l’altro.
Per certi versi ciò sembrerebbe richiamare alla mente l’orfismo del mondo greco dei secoli VI e V a.C., ma con questo condivide solo delle mere somiglianze estrinseche. Come per la dottrina gnostica, anche nell’orfismo abbiamo il concetto che l’anima è percepita come un essere divino imprigionato in un corpo, non per una singola esistenza ma in molteplici (palangenesia). Lo scopo è quello di interrompere il ciclo delle reincarnazioni per giungere agli dèi (o a Dio, nel caso degli gnostici).
A differenza degli gnostici, però, per gli orfici il mondo non è visto come opera di potenze divine malvagie e inferiori, e non vi è alcun interesse per il mondo fisico.
Il male è attribuito alla presenza della corporeità, della materia, e alla decadenza della componente razionale dell’anima, che si piega alle esigenze del corpo e ai suoi istinti. Il mondo non è quindi malvagio in quanto tale, ma al contrario in esso e nella natura si manifesta il divino, che l’ha prodotto e lo regola.
Il sé dello gnostico, il suo vero Io appare interiormente lontano dal mondo, ma esteriormente distante da Dio.
Il problema dell’uomo è il problema dell’origine dell’anima stessa. Questa nei testi gnostici è indicata col termine psyché, mentre lo pneuma è lo spirito. Queste parole non esprimono solo la soggettività “psicologica”, o la coscienza, ma contengono significati più profondi.
Spesso indicano un fluido o un seme, una sorta di divina sostanza, che è andata perduta a causa di un incidente accaduto nella sfera divina. L’origine del male dunque consisterebbe in uno squilibrio della sfera divina. Perciò l’origine del male è in Dio, non perché questo sia malvagio, ma perché nella sua complessa struttura (Pléroma) si sono aperte delle falle che hanno disperso una parte di dynamis, forza divina, la quale sarebbe poi andata dispersa in un tenebroso vuoto, dando così origine anche all’anima.
L’anima è dunque un elemento intrinseco del divino. L’anima e Dio sono la stessa cosa: è vita, non creazione.
L’anima designa l’identità profonda, l’elemento divino che è in ognuno di noi. Questa è perciò il fulcro dell’ambivalenza tra il sé e l’altro, tra il corporeo e lo spirituale.
L’ambivalenza può esser superata solo attraverso la conoscenza (la gnosi – γνϖσις -appunto), la quale si esplicita nella metafora del viaggio, che si suddivide in due momenti fondamentali: il kàtados e l’anodos.
L’ascesa dell’anima è il momento culminante del pensiero salvifico gnostico, che non si realizza solo post mortem, ma anche attraverso esperienze estatiche.

Ph. Martina Cammerata Photography
In questa visione, il soggetto conoscente è l’anima. Essa, proprio attraverso questo percorso conoscitivo, è in grado di purificare sé stessa. La purificazione le permette, conformandosi a ciò che è irriducibilmente altro da sé, di “vedere faccia a faccia il Figlio di Dio”, usando l’amore come strumento.
Per gli gnostici, la conoscenza è consenso alla diminuzione, la quale può attuarsi solo dopo aver preso coscienza da parte dell’anima della sua duplicità. Una volta che essa si libera della carne mortale, può percorrere un percorso di purificazione verso l’alto.
Questo percorso ascensionale ha il preciso scopo di ricongiungere, secondo sostanza, un elemento a ciò che gli è identico, attraverso un processo in grado di risvegliare la scintilla dello spirito divino, che giace assopita nell’essere umano. Nel contempo, si annulla la parte psichica, intrisa di materialismo e mortale.
Coloro nei quali questo percorso giunge al termine, sono essi stessi considerati come facenti parte di questa luce divina. Sono, quindi, in grado di sacrificare il proprio Io per immedesimarsi impersonalmente nella manifestazione del Cristo interiore.
Come Gesù, sono degli dèi salvati, in grado di salvare.
Il tema centrale della dottrina gnostica è quindi il ritorno: a seguito della caduta, le scintille divine sono rimaste imprigionate nel mondo materiale, e il compito dello gnostico è riuscire a ricongiungere la propria luce divina con quella di Dio, attraverso la conoscenza di sé e del suo stato.
Il Paradiso, dunque, altro non è che la propria anima conscia e risvegliata, consapevole della sua essenza e quindi in grado di sfuggire alla reincarnazione.
Perciò, Dio non risiede in un luogo, ma vive in ogni essere umano, celato nella sua più profonda essenza, e sta a all’uomo ritrovarlo attraverso il percorso di conoscenza. Egli aspetta nascosto come un fiore pronto a sbocciare, e l’acqua con cui questo fiore va annaffiato è proprio la conoscenza.

Lo gnosticismo nasce e si sviluppa presso Alessandria d’Egitto, racchiudendo in sé i retaggi della filosofia greca, l’antica religione politeista, e accogliendo le due religioni rivelate. Gli gnostici operano anche una rilettura e nuova interpretazione dei testi sacri: il dio veterotestamentario ai loro occhi appare come un’ignorante essere divino inferiore, che ha il compito di ordinare il mondo materiale, ma che non partecipa dell’essenza della luce divina. Egli cerca di allontanare e far dimenticare all’uomo la sua vera natura. In questo compito è coadiuvato dagli arconti.
In tal senso, molte figure generalmente considerate in maniera negativa dai cristiani, vengono riabilitate, come nel caso di Eva (colei che dona la Zoé), il Serpente (anticipazione del Logos), Maria Maddalena (prototipo del perfetto discepolo), e Giuda (secondo loro, l’unico che aveva appieno compreso la missione di Cristo. Col suo gesto infatti permette a Gesù di liberarsi del corpo.).
La crisi della razionalità greca
Il pensiero filosofico di matrice greca di età classica e ellenistica non ignora l’esistenza del divino, ma non prende in considerazione la nozione di rivelazione divina, affidata alla trasmissione orale o fissata su testi scritti, alla cui interpretazione sono deputati degli specialisti, ossia i sacerdoti.
La crisi della fiducia circa la capacità della ragione umana di giungere alla verità porta al progressivo aumento di rivelazioni da parte di divinità, che aiutano a comprendere non solo la natura del divino, ma anche fenomeni fisici, atmosferici, astrali. Proprio tra III e IV secolo conoscono ampia diffusione l’ermetismo, l’alchimia, l’astrologia e l’oracolistica.
Il chiedere dei responsi agli oracoli è una pratica molto antica e radicata, ma in questo momento si tramutano in una sorta di “oracoli teologici”, con responsi che affrontano rivelazioni sulla natura di Dio, del cosmo, e dell’uomo. A questi si rivolgono soprattutto intellettuali pagani.
Data la fervente ascesa di certe dottrine, anche la legislazione imperiale tardo antica si sente costretta ad intervenire contro maghi e astrologi.
Esiste un monoteismo pagano?
Durante l’età imperiale si fa largo la consapevolezza di una trascendenza, idea nata in seno alla filosofia medio e neoplatonica. La nuova visone teologica di tipo piramidale contempla un principio divino unico trascendente, al di sotto del quale vi è una schiera di demoni (malvagi e benevoli) e divinità minori, intermediari fra gli uomini e Dio.
Per giungere a Dio non sono necessari sacrifici, incompatibili con l’idea del divino, ma va perseguita una via intellettuale.
Con questa premessa più che di monoteismo, si potrebbe parlare di enoteismo, ovvero la preminenza di un dio su tutti gli altri.
La scuola neoplatonica di Atene sopravvive almeno fino al 529 d.C., anno in cui l’editto di Giustiniano ne decreta la chiusura definitiva. Nonostante sia continuata ad esistere fino al VI secolo, la scuola aveva perso gran parte del suo fervore e slancio intellettuale. Già nel IV secolo, Pallada, parlando dell’ultima generazione di pagani colti dice: “Se noi siamo vivi, la stessa vita è morta”.

Ph. Martina Cammerata Photography
Conclusione
Le cause che portano alla dissoluzione della religione pagana sono molteplici, e vanno rintracciate in primo luogo in una profonda crisi istituzionale e sociale. L’antica religio non riesce a soddisfare le intime esigenze dell’individuo, che più che rivolgersi agli dèi per la salvaguardia e l’incolumità dello Stato, è alla ricerca di un’affermazione di sé stesso come singolo, e non come parte di una comunità.
L’attenzione è quindi rivolta, in un primo momento, a culti di provenienza orientale, di matrice misterico-salvifica, che assicurano ai fedeli un’esistenza beata dopo la morte. Questi dèi non richiedono alcun atto di conversione né tantomeno di esclusività. Si hanno infatti testimonianze di persone dedite ai più culti.
Caso noto è quello di Vettio Agorio Pretestato, esponente dell’élite senatoria pagana, morto nel 384 d.C. Nel suo epitaffio sepolcrale si può leggere: “augur, pontifex Vestae, pontifex Solis, quindecemvir, curialis Herculis, sacratus a Liber e nei misteri eleusini, ierofante di Ecate, neocorus di Serapide, tauroboliatus, pater patrum“.
Nonostante questo, però, sono culti rivolti solo a uomini o a donne, o a persone appartenenti a una determinata classe sociale (come nel caso di quello mitraico).
I punti di forza che faranno del cristianesimo la religione predominante, pur con tutte le sue correnti, saranno proprio l’esclusività del culto, il fatto che sia rivolto a tutti senza distinzioni di sesso o rango, e la strutturata gerarchia ecclesiastica, la quale ha il compito di stabilire i principi della fede, che devono essere uguali per tutti e non soggetti a differenze regionali o culturali.

Ph. Martina Cammerata Photography
Bibliografia essenziale
AA.VV. 2005, Antiche vie all’Eternità. Colloquium internazionale sugli aspetti dell’ascesi nei primi secoli del cristianesimo
A. Giovannini 1996, Corredi funebri da tombe ad incinerazione di Aquileia, località Beliuna in Quaderni Friulani di Archeologia VI, pp. 41 – 46
A. Giovannini 2001, Riflessioni sui culti di salvezza ad Aquileia: la presenza di Iside in Orizzonti del sacro. Culti e santuari antichi in Altino e nel Veneto orientale, pp. 289 – 304
A. Giovannini 2002, Bronzetti isiaci dal Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, in Antichità Altoadriatiche, pp. 227 – 251
A. Giovannini 2005, Divinità femminili ad Aquileia. Spunti di ricerca sulla presenza di Iside da reperti scultorei e corredi funebri in Histria Antiqua XIII, pp. 377- 387
A. Giovannini 2012, Aquileia e l’archeologia funeraria tardoantica. Censimento dei dati, tracce di usi e costumi in Aquileia Nostra, pp. 217 – 241
A. Giovannini 2013, Aquileia nel IV secolo. Tra Teodoro e gli antichi dei in Costantino e Teodoro. Aquileia nel IV secolo, pp. 102 – 111
A. Giovannini 2018, “In contrada Beligna… acqua sulfurea”. La presenza ad Aquileia di acque termali tra antico e moderno in Antichità Altoadriatiche LXXXVIII, pp. 363 – 385
A. Giovannini, Spunti di riflessione su alcuni aspetti del culto di Beleno e di Antinoo. Divinità salvifiche ad Aquileia. Evidenza archeologiche e modalità religiose, pp. 157 -170
M. V. Cerutti 2008, La crisi del mondo religioso tardoantico in Cromazio di Aquileia. Crocevie di genti e religioni, pp. 176 – 183
A. Chapula 2005, Hyenas or Lionesses? Mithraism and Women in the Religious World of Late Antiquity in Religio: Revue pro religionistiku, pp.198 – 228
M. De Marre, Aelia Arisuth – Mithraic matron or popular patron?
C. Giordani 2019, Scavo alle origini della comunità cristiana di Aquileia: il mosaico gnostico in Bestie e mostri ad Aquileia
C. Giordani 2020, Il cristianesimo egiziano di Aquileia
G. Pressacco, R. Palluzzano 2002, Viaggio nella notte nella chiesa di Aquiliea
M. Vidulli Torlo 2008, Aion leontocefalo in Cromazio di Aquileia. Crocevie di genti e religioni, pp. 196 – 199
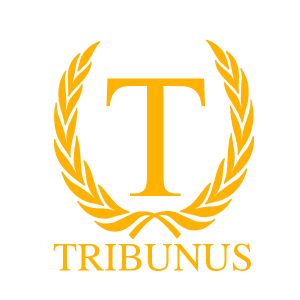

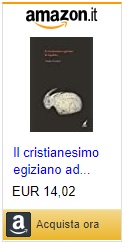
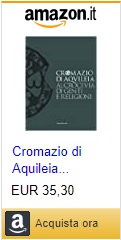
9 thoughts on “Roma tra paganesimo e cristianesimo. Viaggio nelle “religioni della crisi” (III-IV sec. d.C.)”