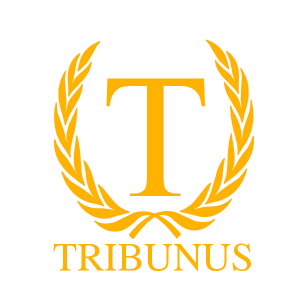Un po’ di Storia
La colonia romana di Cosa venne fondata nel 273 a.C., a seguito della sconfitta delle forze alleate di Volsinii (odierna Orvieto) e Vulci, per aver il controllo suoi territori appena acquisiti. Il luogo scelto per la fondazione del nuovo insediamento era un’altura a 114 metri sopra il livello del mare, a sud del promontorio dell’Argentario, e poca distanza dalla via Aurelia.
Il nome della città potrebbe derivare da un toponimo etrusco Cusi o Cusia, che sorgeva in mezzo alla laguna sul luogo dove attualmente si trova Orbetello (GR).
La posizione strategica, la presenza di due bacini portuali (quelli del Portus Cosanus e del Portus Feniliae) e di un vasto entroterra agricolo furono le principali motivazioni che spinsero i Romani a occupare e fondare una colonia all’indomani della sconfitta di Vulci e in previsione di un attacco cartaginese.
Alla fase della prima deduzione coloniale risalgono le possenti mura di cinta poligonali, realizzate senza impiego di malta o altri leganti ma attraverso la sovrapposizione di grossi blocchi calcarei privi di taglio regolare. La cinta muraria si estendeva per circa un chilometro e mezzo, ed era munita di diciannove torrioni, di cui diciotto a base quadrata, e tre porte urbiche, attualmente note come Porta Fiorentina (la più grande delle tre), Porta Romana, e Porta Marina.
Inoltre, la presenza del Portus Cosanus conferma le motivazioni strategiche della scelta del sito: il ritrovamento di un rostro bronzeo iscritto appartenente ad una nave romana affondata durante la battaglia delle Egadi conferma che Cosa ebbe un ruolo nella costruzione della flotta romana nel periodo della Prima Guerra Punica (264 – 241 a.C.).
Ma fu quando la città mutò la propria vocazione da miliare in commerciale, sfruttando la straordinaria posizione, che la sua struttura urbana assunse la fisionomia definitiva. Cosa possedeva infatti un foro con edifici civili e un’acropoli. La città ebbe una seconda deduzione coloniale nel 197 a.C.
Introno al 70 a.C., la città venne saccheggiata probabilmente da alcuni pirati che infestavano le acque della costa dell’Etruria, e la vita urbana subì una forte battuta di arresto, almeno fino al periodo del Principato: la città fu lasciata in rovina per almeno quarant’anni, quando fu ripopolata probabilmente da un gruppo di veterani in congedo delle legioni di Augusto.
Proprio fra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. l’area del foro e l’acropoli subirono importanti rifacimenti.
Alla ripresa di età augustea e giulio-claudia sono riferibili le testimonianze residenziali nel quartiere attorno al Foro, che testimoniano anche una riduzione dell’abitato entro le mura urbane.
Attorno al II secolo d.C., la città conobbe nuovamente un momento di declino, anche se non mancarono attimi di ripresa edilizia e di riassetto urbano. Nel III secolo d.C., Cosa registrò una breve rinascita, favorita forse dal rinnovato interesse imperiale per il suo centro fortificato e il fertile territorio circostante. Alcune iscrizioni ricordano restauri imperiali dell’area centrale, come quello del tempo di Massimino il Trace, e cambiamenti di destinazione d’uso di alcune aree dell’abitato, ormai ridotto nelle sue dimensioni.
A questo periodo, risale inoltre l’allestimento di un Mitreo in una delle celle dell’antica Curia, ormai abbandonata.
Tale ripresa non durò ancora molto allungo: già nel secolo successivo diminuì l’estensione della superficie urbanizzata, e cessarono i lavori di manutenzione dell’area portuale e della Tagliata (che avremo modo di vedere meglio in seguito). Al IV secolo risale la costruzione di un piccolo santuario dedicato a Bacco o forse a Liber Pater nell’area sud-orientale del foro, centro di culti e cerimonie di tipo misterico. Sul finire del secolo, la città venne nuovamente abbandonata, ma il santuario rimase in uso.
Sulle cause della decadenza della città di Cosa si è scritto molto, senza però giungere a una causa univoca. Per alcuni, un ruolo determinante potrebbe averlo giocato l’assenza di un acquedotto urbano, o l’attrazione del territorio con la sua produzione agricola.
Nel V secolo d.C., la città risulta quasi completamente disabitata. Lo stato in cui versa Cosa è ben espresso dai versi di Claudio Rutilio Namaziano nel suo 𝐷𝑒 𝑅𝑒𝑑𝑖𝑡𝑢 (I, 279 – 287), dove riporta anche incredulo una diceria popolare, secondo la quale l’abitato sarebbe stato lasciato a sé stesso in seguito a un’invasione di topi. Sempre in questo periodo, alcune strutture, forse riferibili a una mansio o a un castellum, vennero edificate nell’area dell’acropoli.
Tra il VI e il VII secolo d.C., sempre nella zona dell’acropoli furono installate strutture per l’immagazzinamento di cereali, ricoveri per animali, e un castrum. Nell’area del foro, all’interno del edificio basilicale, venne invece edificata una chiesetta con annesso un cimitero, e due forni per il pane.
Forse proprio a questo periodo è da ascrivere il mutamento del nome della città da Cosa ad Ansedonia (il nome attuale), probabilmente derivato dal greco sitonia, termine per definire granaio.
Visitare la città
Attualmente è possibile visitare ciò che resta della città di Cosa. Una volta varcate le possenti mura poligonali, passando per Porta Fiorentina, ci si trova catapultati indietro nel tempo in un perfetto connubio fra storia e natura. Il sito archeologico ospita anche la sede del Museo archeologico nazionale di Cosa, risultato di una collaborazione fra lo Stato italiano e l’American Academy in Rome, che per molti anni ha condotto campagne di scavo nella vasta area archeologica. La peculiarità del museo, oltre che per la sua collezione ovviamente, è che l’edificio sorge su dei resti di un’abitazione romana del I secolo a.C., nota col nome di Casa del Tesoro. Durante alcuni scavi condotti negli anni ’70 nell’insula, dove è situata la casa in questione, venne rinvenuto infatti un tesoretto composto da ben duemilaquattro monete. Queste erano state volontariamente sepolte sotto il pavimento della dispensa della dimora, attorno al 70 a.C., anno dell’incursione pirata.

Ph. Martina Cammerata Photography
Gli oggetti esposti nel museo mostrano come doveva svolgersi la vita all’interno della città di Cosa.
Le mura
Dal momento della sua fondazione nel 273 a.C. si provvide subito a dotare la città di un sistema di difesa, costituito da una possente cinta muraria che si sviluppa per circa 1500 m, e che ancora oggi giunge sino a 10 m di altezza.
A rinforzo della mura vi sono diciannove torrioni, di cui diciotto a base quadrata e uno circolare.

Ph. Martina Cammerata Photography
Le mura di Cosa sono realizzate in opera poligonale, un tipo di muratura a secco caratterizzato dall’impiego di blocchi squadrati sagomati sulla faccia a vista. Questo sistema è ampiamente diffuso in ambito mediterraneo.
Le mura hanno tre punti di accesso, noti come Porta Fiorentina, Romana, e Marina.
L’acropoli
Il fulcro della vita religiosa di Cosa è rappresentato dal Capitolium, il principale tempio edificato nel 150 a.C., e oggetto di numerosi restauri fino all’età severiana.
Tra il pronao e la cella è ancora visibile la grande cisterna, da cui provengono alcuni frammenti della decorazione architettonica del precedente Tempio di Giove.

Ph. Martina Cammerata Photography
Un’altro tempio, costruito attorno al 170 – 160 a.C., potrebbe essere dedicato a Mater Matuta, dea dell’Aurora, madre del nuovo giorno, e protettrice delle nascite.
Il foro
La realizzazione del Foro risale al periodo immediatamente successivo alla fondazione della colonia.
Il Foro di III secolo a.C. non si presentava ovviamente articolato come lo sarà nei secoli successivi, ma comprendeva una curia, delle cisterne per garantire il rifornimento idrico, e un carcer. Nel II secolo a.C., su tre lati del Foro si costruirono edifici privati. Al 175 a.C. risale la costruzione del Tempio della Concordia, mentre al 170 a.C. l’arco d’ingresso monumentale. Verso la metà del II secolo a.C. venne anche edificata la basilica.

Ph. Martina Cammerata Photography
La basilica venne edificata attorno al 150 a.C., e venne subito dotata di una cisterna sotterranea.
Per volontà di Nerone, legato alla città poiché la famiglia degli Enobarbi aveva dei possedimenti nella zona, a seguito del terremoto del 51 d.C. e del conseguente restauro, promosse la costruzione di un 𝑜𝑑𝑒𝑢𝑚 all’interno della vecchia sede giudiziaria.
Nel corso del VI secolo d.C., all’interno della basilica venne ricavata una piccola chiesa con cimitero annesso.
A partire dal IV secolo d.C., l’area del Foro verrà utilizzata per attività agricole e come sede di piccole strutture religiose.
Le case
Le abitazioni più antiche, edificate all’inizio del II secolo a.C., non mostrano molte differenze fra loro, ma presentano piante pressoché identiche. Ma già dal secolo successivo, alcune dimore esemplificano un processo di diversificazione sociale ed economica. A queste appartiene ad esempio la casa del mercante Q. Fulvius, di cui abbiamo già accennato in proposito al tesoretto. Un’altra appartenente a questa tipologia è la cosiddetta Casa dello Scheletro, così chiamata per via del rinvenimento effettuato in una cisterna di alcuni resti di un individuo maschio adulto di età compresa tra i 35 e i 50 anni. La dimora, forse su due livelli, era incentrata sull’impluvium, su cui si affacciavano ambienti con pavimenti musivi e pareti rivestite da intonaci dipinti, mentre un porticato immetteva in un ampio giardino. Il triclinium mostra tracce di una decorazione parietale in I Stile Pompeiano.
La Casa dello Scheletro venne distrutta nel 70 d.C., ma nel periodo del Principato, l’area fu bonificata e livellata per permettere la realizzazione di un orto e dei ricoveri per animali domestici.

Ph. Martina Cammerata Photography
Il Portus Cosanus
“𝐷𝑜𝑝𝑜 𝑃𝑢𝑝𝑢𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑐’𝑒̀ 𝐶𝑜𝑠𝑎, 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎̀ 𝑝𝑜𝑐𝑜 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎 𝑖𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑒. 𝑆𝑜𝑝𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑎 𝑐’𝑒̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎, 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎̀. 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑑’𝐸𝑟𝑐𝑜𝑙𝑒 𝑒̀ 𝑑𝑖 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒, 𝑒 𝑣𝑖𝑐𝑖𝑛𝑜 𝑐’𝑒̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑒 𝑑𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑎 𝑠𝑖 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑖”.
Queste sono le parole con cui Strabone (5, 2, 8) descrive Cosa all’epoca del Principato di Augusto.
L’area in cui venne edificato il Portus Cosanus presenta caratteristiche topografiche atte forse ad aver influenzato la scelta del luogo per la fondazione della colonia stessa.
Il Portus Cosanus è il più antico porto romano conosciuto. Le prime installazioni portuali furono opere finalizzate alla realizzazione di un approdo sicuro, evitare l’insabbiamento del porto, e permettere la migrazione dei pesci sfruttando un’insenatura naturale nota come Spacco della Regina.

Ph. Martina Cammerata Photography
Nella prima metà del II secolo a.C., questa però si insabbiò, e venne sostituita da un’opera artificiale scavata nella roccia.
Sull’altura prospicente la laguna a nord-ovest, sorgeva un piccolo tempio italico a una cella, di cui sono stati alcuni resti della decorazione fittile. Si ipotizza che il tempio fosse dedicato a Nettuno, dio del mare e delle sorgenti, protettore dei marinai e dei pescatori, creatore del primo cavallo per l’umanità, come anche ben testimoniato da alcune monete cosane che mostrano sul rovescio una protome equina su un delfino. L’edificio venne edificato nel secondo quarto del II secolo a.C., e ricostruito nel primo quarto del I secolo a.C.
Letture consigliate
AA. VV. 2018, Cosa: colonia romana con vista in Archeologia Viva
M. Celuzza 2010, Il De Reditu di Rutilio Namaziano e l’archeologia tardo antica delle coste tirreniche in Il mare degli antichi, pp. 193 – 232