L’origine legale della famiglia era costituita dal matrimonio.
Questo era preceduto dallo sponsalia, il fidanzamento, che prevedeva il consenso dei diretti interessati, e per il quale era richiesto il compimento del settimo anno d’età.
Il fidanzamento era accompagnato da uno scambio di doni. Nel caso di decesso di uno dei due fidanzati, tali doni andavano restituiti, a meno che non ci fosse stato almeno un bacio (come prevedeva una legge del 336): in tal caso, ne sarebbe stata restituita solo la metà.
La rottura del fidanzamento senza una giusta causa comportava, invece, il pagamento del doppio del dono di fidanzamento. Un ritardo di almeno due anni nell’onorare la promessa nuziale, avrebbe invece consentito alla fanciulla di contrarre matrimonio con un altro uomo.
Per il matrimonio vero e proprio, comunque, bisognava aspettare il raggiungimento dell’età legale della pubertà – quattordici anni per i ragazzi, dodici per la ragazze.
La donna, dopo il matrimonio, non entrava a far parte della famiglia del marito, ma restava sotto la tutela paterna, o indipendente (se già lo era).
Ella poteva disporre dei propri beni, con l’assistenza temporanea di un tutore (dote esclusa, poiché questa era considerata come il contributo che la fanciulla portava alle nozze). Della dote il marito poteva disporre a suo piacimento, ma era tenuto alla restituzione in caso di scioglimento del matrimonio.
Fidanzamento e matrimonio potevano avvenire soltanto tra persone libere, che non avessero stretti legami parentali (al fine di evitar legami incestuosi). Tutori e curatori non potevano sposare la persona loro affidata, se questa aveva meno di ventisei anni, e senza una speciale autorizzazione.

Ph. Amok
Altri divieti vennero stabiliti poi da alcune leggi. Ad esempio: nel 373, l’imperatore Valentiniano I proibì le unioni coi barbari; nel 388 Teodosio vietò ad ebrei e cristiani di sposarsi fra loro; nel 530, Giustiniano impedì al clero inferiore di contrarre matrimonio.
In caso di violazione di tale norma, i figli nati da queste ultime unioni erano da considerarsi il frutto di un’unione incestuosa. In Oriente, vi erano generalmente leggi meno severe nei confronti del clero, anche se era comunque proibita l’ordinazione a vescovo di coloro che avessero avuto mogli, figli, e nipoti, anche se vedovi.
Ai senatori e alla loro prole era proibito convolare a nozze con attori e liberti.
Tuttavia, l’imperatore Giustino I, su pressione del nipote, lo permise nel caso degli attori, ma solo se questi ultimi avessero smesso di praticare la professione. Infine, in caso di schiavitù era permessa solo una convivenza, contubernium, privo di effetti giuridici.
Gli schiavi non potevano sposarsi tra loro. Era consentita solo un’unione di fatto col consenso del padrone, che poteva annullarla a suo piacimento, ed i loro figli erano schiavi.
In una situazione analoga, si trovavano i servi della gleba (i coloni che lavoravano i campi dei latifondisti): si potevano sposare con donne libere, ma affinché i figli di queste unioni fossero considerati uomini liberi a loro volta, bisognò aspettare la legislazione di Giustiniano.
La legge, però, causò lo scontento dei proprietari terrieri.
Per quanto riguarda l’adulterio, già severamente punito sin dal tempo di Augusto, vigevano leggi molto aspre.
Costantino stabilì la pena di morte e la confisca dei beni per l’uomo adultero, ma mantenne l’antica tradizione dell’esilio per la moglie rea di tradimento.

Tuttavia, l’adulterio di un uomo con una donna nubile non era punito.
Essendo una questione privata, dovevano esser il marito o parenti prossimi ad accusare la donna, a meno che il reato non fosse stato commesso con uno schiavo: in questo caso, la questione diventava pubblica, la donna veniva condannata a morte e lo schiavo arso vivo. Nel 339, i successori di Costantino andarono oltre, punendo gli adulteri col culeus (i.e. essere chiusi in un sacco con bestie come cani o galli, per poi essere gettati in mare o in un fiume), come si faceva con i parricidi. A Roma, invece, le adultere erano costrette a prostituirsi.
Teodosio I abolì quest’usanza, ma assimilò il crimine alle nozze contratte con un giudeo.
Valentiniano I impose la pena di morte per le donne accusate di adulterio, ma venne già abolita nel V secolo da Maggioriano, che ristabilì l’esilio di antica tradizione. Giustiniano, invece, legiferò che un uomo non avrebbe potuto ripudiar la moglie senza che prima questa non fosse stata condannata per il suo crimine. Confermò la pena di morte per il marito adultero, sopprimendo però la confisca dei beni; la donna avrebbe potuto recuperare la dote o un quarto dei possedimenti del marito.
Per la donna adultera era prevista la fustigazione e l’internamento in un monastero, da dove sarebbe potuta uscire solo se il coniuge fosse andato a riprenderla dopo due anni. In caso contrario, il matrimonio era sciolto. Al monastero, quindi, andavano anche i beni della donna, o una parte di essi se la donna aveva già avuto figli.
Inoltre, la legge tutelava i padri che assassinavano le figlie colte in fragrante d’adulterio nella propria casa o in quella del genero, anche se uccideva anche l’adultero. Se invece avesse risparmiato uno dei due, sarebbe stato accusato d’omicidio.
Il marito che uccideva la moglie era altrettanto giustificato, ma poteva assassinare anche l’adultero solo se già questo avesse avuto precedenti penali, o fosse stato uno schiavo, un liberto, un ruffiano, o un giocatore d’azzardo. Se il marito non si macchiava del sangue della moglie adultera e dell’amante, doveva ripudiare la donna immediatamente, per non esser accusato di lenocinio.
Nel 542, Giustiniano affermò che un uomo avrebbe potuto uccidere un altro uomo, anche solo sospettato d’adulterio, se dopo avergli mandato per tre volte degli avvertimenti, l’avesse sorpreso a conversare con la moglie. Oppure, come soluzione molto meno cruenta, poteva rivolgersi al vescovo.
Altro crimine gravissimo era l’incesto, punito con la morte e la confisca dei beni. Questa pratica, però, era tollerata in Egitto, Mesopotamia, ed Osroene, dove andarono avanti fino al VI sec. d.C., perfino tra i membri del clero.
Ugualmente puniti erano lo stuprum e rapporti omosessuali (con pene per il reo ed i complici).
Più tollerante era la legislazione sul concubinato, che poteva aver luogo fra persone libere, o fra queste e schiavi.

Ph. Amok
Il divorzio, invece, suscitò molti contrasti. La libertà di divorziare per mutuo consenso del diritto romano più antico subì una forte battuta d’arresto, anche se venne mantenuto fino al VI secolo. Nel 542, Giustiniano lo proibì definitivamente, a meno che uno dei due coniugi non avesse intenzione di perseguire una vita di castità.
Ma se la norma fosse stata violata, la pena sarebbe stata la reclusione a vita in un monastero, mentre un terzo dei beni del condannato sarebbe andato alla struttura. La sanzione veniva annullata se i due coniugi tornavano assieme, o se uno dei due era disposto a farlo.
L’uomo poteva disporre lo scioglimento del legame matrimoniale per numerosi motivi, tra i quali:
- se il matrimonio non fosse stato consumato per tre anni;
- il desiderio di condurre una vita casta;
- aborto volontario;
- fare il bagno con altri uomini;
- combinare future nozze, mentre si era ancora sposati;
- adulterio accertato;
- per attentato alla vita del marito;
- per esser andata a banchetti o bagni con estranei senza il consenso del marito;
- per abitar all’esterno della casa con estranei;
- presenziare a spettacoli circensi o teatrali senza approvazione.
La donna poteva ripudiare il marito, se questi avesse cospirato contro l’Impero o se avesse nascosto questa volontà al coniuge. Ma anche per:
- aver tentato di prostituirla;
- aver trascurato insidie portate d’altri;
- la falsa accusa d’adulterio;
- accompagnarsi con altre donne in casa o nella stessa città;
- presunzione di morte, in caso cui non si avesse notizia del coniuge prigioniero o disperso in guerra per cinque anni (divortium bona gratia).
Letture consigliate (clicca i link qui sotto per acquistare la tua copia del libro)
G. Ravegnani 2015, La vita quotidiana alla fine del mondo antico
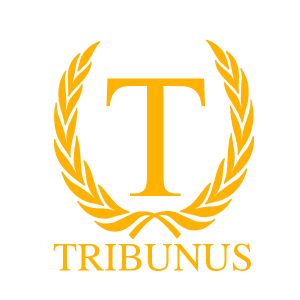
4 thoughts on “Matrimonio e vita coniugale nel periodo tardo antico (IV-VII sec.)”