216 a.C.
Il disastro della battaglia di Canne si è appena consumato.
Con questa disfatta, sarebbe sensato chiedere una tregua…
…ma non per Roma, incapace di arrendersi.
Si predispongono misure straordinarie di reclutamento per proseguire la guerra.
Si chiamano a raccolta i socii, che forniscano nuovi soldati.
Quattro nuove legioni vengono composte da ragazzi di appena diciassette anni o meno (“ancora pretestati”, ci dice Livio).
Ma non basta.
Si stima che Roma abbia ormai perso un quinto della sua popolazione maschile abile alle armi – senza contare i socii.
Si arriva così a una misura senza precedenti: arruolare schiavi.

L’arruolamento degli schiavi…volontari
Eutropio, nel “Breviarium”, afferma che gli schiavi sono prima affrancati e poi arruolati.
Sarebbe sensato, dopo tutto: già altri liberti hanno militato nelle legioni romane in passato.
Ma Livio racconta una storia ben diversa…infatti, lo Stato compra schiavi giovani e in forze dai loro proprietari per arruolarli, senza affrancarli.
Si potrebbero riscattare i prigionieri di guerra: costerebbe molto meno.
Ma un legionario romano catturato con le armi in pugno è considerato un infame, che merita di essere allontanato.
Si preferisce così arruolare gli schiavi. Ben ottomila uomini, due legioni.
Tuttavia, vi è un curioso dettaglio su questo arruolamento: agli schiavi, viene infatti chiesto se abbiano intenzione di arruolarsi.
Per questo sono chiamati “volones“, volontari.
Strano comportamento da tenersi con degli schiavi, ai quali basterebbe dare ordini.
Nella mentalità romana, affine a quella greca in questo senso, è in realtà un passaggio indispensabile.
Secondo Romani e Greci, solo eserciti di liberi possono vincere le guerre.
Un soldato romano non si batte per obbedire al suo comandante, ma obbedendogli. L’autorità del generale non è quella di un padrone sui suoi schiavi.
Si giunge così a questo curioso compromesso, per il quale un’armata di schiavi è inquadrata come fosse composta di uomini liberi.
Di questi schiavi sappiamo poco e nulla. Possiamo immaginare le origini più disparate.
Sappiamo solo che già nel 215 a.C., i volones avranno la loro prima prova del fuoco…a Cuma.
Da schiavi a soldati
215 a.C.
Liternum, Campania.
Al console Tiberio Sempronio Gracco è affidato il nuovo esercito di schiavi-soldato di Roma.
Assieme a venticinquemila socii, Sempronio Gracco ha mosso da Sinuessa, al confine tra Lazio e Campania, e ha attraversato il Volturno.
Si accampa a Liternum.
Guarda i suoi uomini. Schiavi e reclute.
La maggior parte dei volones non ha mai preso in mano un’arma.
Forse tra gli schiavi-soldato c’è qualche prigioniero di guerra, che ha deciso di arruolarsi per avere una seconda possibilità. Ma nessuno di loro è addestrato.
Inizia così un intenso addestramento.
Prima di tutto, si insegna ai soldati a marciare seguendo le insegne, perché in battaglia le riconoscano e sotto di esse si radunino.

La cosa più importante è che tra le reclute si crei coesione, un forte spirito di corpo.
Sempronio Gracco non è uno stupido.
Il console ben immagina tanto lo stato d’animo dei volones (che mentalmente si considerano ancora schiavi), quanto degli ufficiali e dei pochi veterani presenti (che considerano gli schiavi senza animus, incapaci di atti onorevoli).
Bisogna evitare disordini nei ranghi a qualunque costo.
I volones devono diventare veri soldati, motivati, pronti a morire per Roma.
Sempronio Gracco impone ai suoi ufficiali di non prendere in considerazione l’origine servile delle nuove reclute e di non rimproverarli per questo.
“Che il veterano tollerasse di essere uguagliato alla recluta, il libero allo schiavo.
Si stimassero abbastanza nobili e generosi tutti coloro ai quali il popolo romano avesse affidato le sue armi e le sue insegne.”
Le istruzioni di Sempronio Gracco sembrano funzionare.
Dopo un periodo di convivenza e addestramento collettivi, i soldati vanno d’accordo e si stimano gli uni con gli altri.
I Romani quasi dimenticano che i volones sono degli schiavi.
Ma che tale coesione funzioni davvero andrà ancora dimostrato sul campo di battaglia.
La battaglia di Hama
Hama, Campania. Mezzanotte.
I Campani del medix tuticus Mario Alfio dormono tranquilli nel loro accampamento. Altri, ignari, stanno rientrandovi del tutto disarmati.
Non hanno idea che i volones di Sempronio Gracco stiano per abbattersi su di loro…
Tre giorni prima, all’accampamento di Sempronio Gracco si è presentata una delegazione da Cuma.
I Campani, alleati di Annibale, non riuscendo a convincere i Cumani a ribellarsi a Roma, intendono eliminarne o catturarne il Senato.
Con la scusa di un evento religioso comune ai Campani, il Senato cumano è stato invitato a partecipare.
I Cumani mangiano la foglia…è una trappola. Prendono tempo e mandano invece una delegazione a Gracco, spiegandogli la situazione.
Il console non indugia.
Smontato l’accampamento, l’esercito romano si mette in marcia verso Hama, dove si terrà il sacrificio.
Si tratta di una celebrazione particolare, della durata di tre giorni. Il sacrificio deve avvenire prima della mezzanotte.
I Campani sono già radunati per l’evento. Mario Alfio è accampato nelle vicinanze, con quattordicimila uomini.
Il medix tuticus si sta tuttavia curando più di preparare la sua trappola, che di fortificare e far sorvegliare a dovere il suo campo.
Errore fatale.
Sempronio Gracco si accampa a tre miglia da Hama. Ha stimato di colpire intorno alla mezzanotte, subito dopo il sacrificio.
Ed è ora di mettere alla prova i volones.
Gracco ordina ai soldati di andare a dormire all’ora decima (intorno alle quattro del pomeriggio).
Devono essere perfettamente riposati.
E ora, a mezzanotte, dopo averli fatti marciare in silenzio, i soldati del console sono pronti.
La sorveglianza dei Campani è talmente bassa per via della celebrazione, che Gracco ha modo di disporre i suoi soldati tutto intorno all’accampamento nemico.
Viene lanciato il segnale.
L’esercito romano irrompe nell’accampamento campano da tutte le porte.
Volones e socii massacrano tanto i campani immersi nel sonno, quanto gli sfortunati che, disarmati, rientrano dal sacrificio.
I Campani fuggono.

Ph. Martina Cammerata Photography
Nell’agguato notturno, i Romani hanno ucciso duemila uomini, perdendone meno di cento, e catturato trentaquattro stendardi.
Lo stesso Mario Alfio rimane ucciso.
Non vi è però tempo per festeggiare la vittoria.
Gracco raduna i suoi uomini e marcia velocemente verso Cuma.
Prima dell’assalto ai Campani, aveva ordinato ai Cumani di far radunare tutta la popolazione e le vettovaglie necessarie e di trasferirle in città.
Gracco e i volones non possono restare allo scoperto.
A meno di un giorno di marcia da loro, presso Capua, è accampato il nemico più pericoloso di tutti…
Annibale.
L’assedio di Cuma
Sempronio Gracco si è messo in trappola con le sue mani.
Preferirebbe non stare rinchiuso dentro Cuma. Rimane lì più per dovere verso gli alleati cumani, che per fiducia nel suo esercito.
I volones, per quanto reclute, hanno dato buona prova di sé ad Hama…ma è stato un agguato notturno contro un nemico disarmato e inerme.
Annibale è di tutt’altra pasta.
Alla notizia del massacro dei Campani, il condottiero cartaginese si è mosso immediatamente, convinto di cogliere i Romani di sorpresa.
Ha trovato solo un accampamento vuoto.
Annibale ha fatto marcia indietro ed è tornato con tutto l’occorrente per un assedio, accampandosi a un miglio da Cuma.
Le macchine iniziano presto a battere le fortificazioni.
Le mura per ora reggono, sono di aiuto ai soldati più inesperti. Ma non proteggeranno Cuma in eterno.
Annibale non intende tirarla per le lunghe. Fa costruire un’enorme torre d’assedio.
Una volta che i suoi saranno sulle mura, sarà facile avere ragione dei volones di Gracco.
In tutta risposta, il console fa edificare una torre ancora più alta, utilizzando le mura di Cuma come base.
Una volta pronta, la torre cartaginese si avvicina, lenta e inesorabile.
Ormai è appoggiata alle mura.
I soldati di Gracco non aspettavano altro.
Dall’alto della posizione difensiva, gettano sulla torre d’assedio fiaccole su fiaccole.
Ben presto, la torre di Annibale è una torcia. I suoi uomini, terrorizzati, precipitano al suolo e cercano di abbandonarla.
Il momento è perfetto per approfittare del caos appena creato.
Gracco conduce i suoi in una sortita dalle due porte di Cuma, assale l’esercito cartaginese e lo mette in fuga, ricacciandolo nel suo accampamento.

Il giorno è di Sempronio Gracco e dei volones. I Cartaginesi lasciano milletrecento uomini sul campo.
Annibale è convinto che Gracco, esaltato dal successo, lo voglia affrontare in campo aperto.
Il giorno dopo, Annibale si presenta davanti a Cuma con l’esercito in ordine di battaglia…..ma il console è ben consapevole delle sue forze.
Dopo la vittoria del giorno prima, ha fatto ritirare subito i suoi dentro le mura, e lì attenderà.
Che Annibale venga a prenderlo lì dentro, se ci riesce.
Il condottiero cartaginese, per una volta, ha valutato male il suo nemico.
Dopo aver constatato che Gracco non esporrà i suoi al pericolo di una battaglia campale, se ne torna mestamente a Capua.
Contro ogni previsione e sorprendendo anche Gracco, i volones hanno affrontato e vinto la loro prima, vera battaglia.
Ma la guerra è lungi dall’essere finita, e presto gli schiavi-soldato di Roma dovranno tornare ad affrontare i Cartaginesi…e a guadagnarsi la libertà.
La storia dei volones continua qui
Volones. Gli schiavi-soldato di Roma (2)
Bibliografia essenziale
Fonti
Tito Livio, Ab Urbe condita
Valerio Massimo, Memorabilia
Studi secondari
M. Bocchiola, M. Sartori 2008, La battaglia di Canne.
F. Dupont 2000, La vita quotidiana nella Roma repubblicana
N. Fields 2010, Roma contro Cartagine
N. Fields 2012, Roman Republican Legionary 298-105 BC
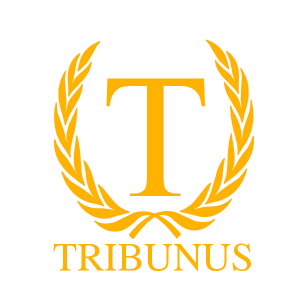
One thought on “Volones. Gli schiavi-soldato di Roma (1)”