Se intorno al 390 d.C. vi fosse capitato di transitare nella provincia della Scizia Minore, a un certo punto del vostro viaggio, non troppo distante dalla foce del Danubio, vi si sarebbe presentato l’inquietante spettacolo di una distesa di ossa umane biancheggianti.
Presso la località conosciuta come ad Salices, nel 377 venne combattuta una sanguinosa battaglia tra i Romani e i Goti.
Nell’ambito della guerra gotica del 376-382, un esercito romano fece il primo tentativo di sconfiggere una forza ben superiore di Goti. Questi ultimi si erano ribellati ai soprusi ai quali erano stati sottoposti fino a quel momento e si erano dati al saccheggio, al comando di Fritigerno. I Goti stavano mettendo a ferro e fuoco la Tracia, e l’impero doveva provare a fermarli.
La battaglia di ad Salices, o battaglia dei Salici, fu il preludio alla ben più famosa battaglia di Adrianopoli, che sarà combattuta l’anno successivo.
L’attraversamento del Danubio e la rivolta dei Goti
Quanto accadde tra la fine del 376 d.C. e la battaglia dei Salici nel 377 è ormai materia piuttosto nota, ma sarà utile ripercorrere velocemente gli eventi.
Tra estate e autunno del 376 d.C., un’enorme massa di Goti fuggiva dalle proprie sedi a causa di un nuovo e temibile popolo di guerrieri a cavallo emerso dalla steppa eurasiatica: gli Unni.
I Goti, divisi nei loro vari popoli (tra quelli nominati dalla nostra fonte principale, Ammiano Marcellino, i principali sembrano essere stati i Greutungi e i Tervingi, questi ultimi poi confluiti nei Visigoti), si presentarono sulla sponda settentrionale del basso Danubio, chiedendo di poter essere accolti dalla superpotenza che governava dall’altra parte, l’impero romano.
L’imperatore Valente, in quel momento ad Antiochia, impegnato a preparare la nuova campagna contro i Persiani, decise di accogliere la moltitudine dei Goti in territorio romano – se sentendosi incredibilmente fortunato per tutte le nuove reclute ora disponibili grazie ai Goti, o se controvoglia e solo perché impossibilitato a bloccarli come pensano alcuni storici contemporanei, non è dato saperlo.
Si tenga presente che Valente aveva condotto una campagna contro i Goti pochi anni prima, per quanto senza combattimenti.
I Goti, sotto la supervisione delle autorità romane, avrebbero dovuto attraversare il fiume presso Durostorum per poi essere condotti alla grande città più vicina, Marcianopoli.
Da lì, sarebbero diventati nuovi coloni e nuovi soldati da integrare nelle truppe dell’imperatore in Oriente.
Tuttavia, come è noto, gli eventi presero una piega terribile e inarrestabile, a causa dell’avidità e della corruzione degli ufficiali romani coinvolti nelle operazioni – a partire dal comandante delle truppe di Tracia, Lupicino. Affamati dagli stessi Romani, costretti a vendere persino i propri figli per un po’ di pessimo e scarso cibo, impossibilitati a poter raggiungere le loro nuove sedi nel territorio imperiale, i Goti iniziarono a rumoreggiare pericolosamente.
Ciò sì spinse i Romani, resisi conto della gravità della situazione da loro creata, a condurli finalmente a Marcianopoli, ma anche a meditare come uccidere i capi dei Goti, per renderli inoffensivi. Lupicino pensò di potersi sbarazzare dei capi gotici, tra cui Alavivo e il più famoso Fritigerno, isolandoli dal resto dei loro e assassinandoli durante un banchetto.
La congiura fallì miseramente, proprio mentre i Goti all’esterno delle mura della città, esasperati, avevano attaccato e ucciso i soldati romani che dovevano far loro da scorta, impossessandosi delle loro armi.
Guidati da Fritigerno, i Goti iniziarono a saccheggiare e devastare le campagne della Tracia, come tremenda vendetta per quanto accaduto loro fino ad allora, e più interessati a sopravvivere che non a cercare nuovi accordi.
Lupicino, che era riuscito a sottrarsi ai tumulti, si presentò poco dopo per affrontare i Goti alle porte di Marcianopoli con un esercito raccolto in tutta fretta, che avanzava “più temerariamente che prudentemente”, come commenta Ammiano.
Fu un disastro. L’esercito romano fu sconfitto dalla massa inferocita e disperata dei Goti, vessilli e armi caddero, Lupicino si rifugiò a Marcianopoli, abbandonando i suoi uomini al loro destino.
I Goti, ora, “indossate le armi romane, devastarono varie zone senza che nessuno si opponesse”.
La rivolta dei Goti era cominciata.

L’ammutinamento di Suerido e Colias e l’assedio di Adrianopoli
Mentre si consumavano gli avvenimenti di Marcianopoli, due contingenti di Goti attendevano di vedere che piega avrebbero preso gli eventi.
Questi due reparti, dei quali le fonti non ci indicano la consistenza, erano guidati dai comandanti Sueridas e Colias. Erano una forza di guerrieri goti accolti e arruolati già molto tempo prima all’interno dei confini imperiali, e posti di stanza ad Adrianopoli.
Come commenta Ammiano, “Sebbene queste notizie [sulla rivolta] fossero state diffuse da continui messaggi, Suerido e Colias […] ritenendo che la propria salvezza fosse la cosa più importante, osservavano con indifferenza quanto accadeva.”
Un atteggiamento che, se a posteriori può sembrare ambiguo, è in realtà ben comprensibile. Se unendosi ai Romani le cose si fossero messe male, i Goti di Fritigerno avrebbero probabilmente infierito molto pesantemente su di loro. Inoltre, e forse cosa più importante, gli eserciti e la popolazione romana della Tracia, impauriti dalla nuova minaccia dei Goti, avrebbero probabilmente visto Suerido e Colias come nemici.
E questo fu esattamente ciò che accadde.
Suerido e Colias ricevettero improvvisamente una lettera dall’imperatore: ordinava loro di mettersi immediatamente in viaggio per attraversare l’Ellesponto, probabilmente per raggiungerlo e rimpinguare i suoi ranghi, in vista della campagna contro i Persiani. Le tempistiche sembrano fin troppo strette, perché si possa pensare a una misura preventiva per allontanare i Goti di Adrianopoli dai loro connazionali in rivolta, ma non è un’ipotesi del tutto da escludere.
Suerido e Colias si misero in moto per obbedire agli ordini. Con le loro truppe si presentarono in città e al magistrato di Adrianopoli “chiesero senz’arroganza il denaro per il viaggio, vettovaglie ed una dilazione di due giorni”, come riporta Ammiano. La normale prassi per qualunque contingente militare.
Per tutta risposta, il magistrato della città ordinò ai cittadini di armarsi e di massacrare i Goti, con grande sorpresa e sgomento di Suerida e Colias. Ad aggiungersi alla paura per la situazione contingente, probabilmente l’odio del magistrato per i due capi goti, che con le loro truppe avevano recentemente devastato una sua villa di campagna.
I Goti finché poterono mantennero la calma, restando immobili, sottoposti ad attacchi e insulti di ogni genere. Ma ben presto, attaccati da ogni parte e presi di mira da vari dardi, la misura fu colma.
Suerida e Colias diedero l’ordine di attaccare, uccidendo così gran parte dei loro aggressori e mettendoli in fuga. Una volta impossessatisi delle armi romane sul campo, presero l’unica decisione per loro sensata: si unirono ai Goti di Fritigerno, che in quel momento non transitavano troppo distante da Adrianopoli.
Le forze gotiche unite tentarono di assalire Adrianopoli stessa, ma le mura della città e la strenua difesa degli abitanti li costrinsero a ripiegare.
Per i Goti, poco male. L’intera Tracia era a loro disposizione per essere messa a ferro e fuoco, piena di facili obiettivi di saccheggio. Nuovi Goti, sia dispersi sin dall’attraversamento del Danubio che schiavi fuggiti dai loro padroni, andavano a ingrossare giorno dopo giorno le fila di Fritigerno.
La Tracia era in fiamme, e chi aveva aveva fatto scoccare la scintilla non era ormai più in grado di spegnere l’incendio.
I Goti sotto assedio
Le notizie di quanto stava accadendo in Tracia raggiunsero finalmente Valente, ancora ad Antiochia.
L’imperatore decise di abbandonare la campagna di Persia per occuparsi personalmente della minaccia gotica. Mentre lentamente, con l’esercito, si metteva in marcia verso Costantinopoli, mandò avanti due dei suoi comandanti, Profuturo e Traiano, descritti da Ammiano come “assai ambiziosi, ma imbelli”.
Ammiano considera anche le truppe al seguito di Profuturo e Traiano come inadeguate al compito che avrebbero dovuto svolgere. Così le descrive: “[Profuturo e Traiano] opposero ai barbari, che erano ancora fuor di sé per il furore, le legioni condotte dall’Armenia. Esse avevano dato spesso buona prova di sé in combattimento, ma non erano in grado di fronteggiare quell’immensa folla che aveva occupato le giogaie delle più alte montagne e delle pianure. […] non avevano ancora sperimentato che cosa significasse il furore indomito unito alla disperazione.”
L’autore purtroppo non riporta anche quante truppe componessero queste unità dall’Armenia.
Ammiano è estremamente critico anche sulla tattica che i due comandanti decisero di adottare una volta in Tracia. Invece di darsi alla guerriglia e di stanare e distruggere i Goti isolatamente, banda per banda, Profuturo e Traiano inseguirono i Goti e li bloccarono nei territori al di là del massiccio che comprende il monte Emo (identificato con il monte Botev, in Bulgaria). Si trattava di un assedio vero e proprio; come riporta Ammiano, affinché i Goti “non trovassero alcuna via d’uscita e fossero consumati da una lunga fame”.
Il piano di Profuturo e Traiano non prevedeva un assalto subitaneo ai Goti, anche perché erano attesi rinforzi.
Essi attendevano l’arrivo del dux Frigerido, generale inviato dall’imperatore in Occidente, Graziano, con truppe di numero imprecisato provenienti dalla Pannonia e dalla Gallia. Al suo posto, tuttavia, avanzò nei Balcani con le sue truppe Ricomere, comes domesticorum.
Frigerido era affetto da gotta o, come raccontavano allora le malelingue, aveva inventato la malattia per non partecipare a pericolosi scontri.
Sia come sia, quando Ricomere raggiunse Profuturo e Traiano, dovevano esserci stati movimenti di truppe che Ammiano non specifica.
I due comandanti romani erano infatti accampati presso la località nota come ad Salices, nella provincia di Scizia Minore, ad almeno 200 km a nord del massiccio dell’Emo.
Si può ipotizzare che, nell’attesa (o alla notizia) dell’arrivo di Ricomere, i due comandanti di Valente si fossero mossi all’inseguimento del grosso dei Goti nell’area tra le montagne e il Danubio, li avessero finalmente stanati proprio presso ad Salices, rintanati in un enorme carrago, una fortezza di carri, dentro la quale godevano “del riposo e della ricca preda”.
Come si evince dalla successiva narrazione di Ammiano, il carrago doveva trovarsi su un’altura, o essere nelle vicinanze di una collina di qualche tipo.
I Romani avevano intercettato i Goti anche perché Fritigerno, venuto a sapere che l’esercito imperiale gli era alle calcagna, aveva deciso di non spostare più il suo accampamento – cosa che, come riporta Ammiano, i Goti avevano fatto con grande frequenza.
Probabilmente ritenendo di non avere abbastanza uomini validi per fronteggiare un esercito vero e proprio, e non un esercito indisciplinato come quello di Lupicino a Marcianopoli, Fritigerno fece dare ordine alle bande di razziatori ancora sparse nella zona.
Questi ultimi “ricevuti gli ordini dai capi, immediatamente, simili a frecce incendiate, si ritirarono volando alla barricata costituita dai carri […] ed aggiunsero ai loro connazionali un incentivo ad osare imprese più grandi”.
Goti e Romani stavano per affrontarsi nella prima battaglia campale vera e propria dall’attraversamento del Danubio del 376.
La battaglia dei Salici
In entrambi gli schieramenti vi era un grande volontà di combattere, e gli animi erano tesi.
La massa dei Goti, dentro il carrago, “terribilmente fremeva e, eccitata dal proprio animo selvaggio, s’affrettava, fuor di sé dalla bramosia, ad affrontare quanto prima l’estremo pericolo, tanto più che i capi non si opponevano.”
Si era ormai fatta sera, e i Goti “presero cibo a loro agio, ma non dormirono”.
Quanto ai Romani, a quanto pare consapevoli delle intenzioni bellicose dei Goti, “essi pure svegli, temettero i nemici e la pazzia dei loro capi, come se fossero animali furiosi, e s’aspettavano senza timore un risultato incerto, se consideravano che erano inferiori di numero, favorevole se volgevano la mente alla bontà della loro causa.”
Questo brano è l’unico accenno di Ammiano alla consistenza e disparità numerica dei due schieramenti, che purtroppo è praticamente impossibile da stimare.
La battaglia si scatenò all’alba.
Appena sorse il sole, fu dato ordine con buccine e altri strumenti musicali di armarsi per prepararsi allo scontro.
Nella narrazione di Ammiano, che rende molto bene la frenesia che doveva regnare nei due accampamenti, è ben evidenziata la grande differenza tra i modi di prepararsi e scendere in campo – nonché una probabile maggior lungimiranza tattica da parte di Fritigerno.
I Goti “dopo aver giurato reciprocamente secondo il loro costume, cercarono di raggiungere la zona collinosa, onde travolgere successivamente con impeto più violento, simili a ruote, quanti si facessero loro incontro lungo il pendio.”
Mentre Fritigerno precedeva i Romani nell’assicurarsi quella zona tatticamente vantaggiosa, i soldati imperiali in modo disciplinato “si recarono in fretta ognuno ai propri manipoli e, stando fermi senza fare alcun movimento, né si aggiravano qua e là né, abbandonando lo schieramento, correvano innanzi.”
Come non conosciamo bene la consistenza degli eserciti, non sappiamo come fossero organizzati i due schieramenti.
Dalla narrazione, possiamo immaginare due classiche formazioni del periodo, con il grosso dell’esercito, costituito dalla fanteria, al centro, e contingenti di cavalleria sulle ali.
I due eserciti avanzarono lentamente e cautamente l’uno contro l’altro, e alla distanza di tiro delle armi da getto, si fermarono, affrontandosi da distante.
Tanto per spaventare i nemici che per aumentare il proprio morale, i due eserciti lanciavano i loro gridi di guerra: i Romani il barritus, che “debole da principio, cresce poco a poco”, mentre i Goti “con urla selvagge celebravano le lodi dei loro antenati.”
Iniziarono le prime scaramucce tra i due schieramenti, probabilmente scontri tra le fanterie leggere e duelli individuali. Già da tempo era iniziato il lancio di giavellotti e spicula.
Alla fine, Goti e Romani tornarono ad avanzare e le linee cozzarono, in un tremendo scontro.
I due schieramenti “s’erano scontrati in un minaccioso corpo a corpo e, uniti gli scudi a mo’ di testuggine, si serravano gli uni addosso agli altri.”
Nella prima fase della battaglia, i Goti riuscirono a sopraffare e travolgere l’ala sinistra romana, ma furono fermati da un contingente di truppe di riserva. Dalle parole di Ammiano non è chiaro se queste truppe siano giunte da fuori in tempo, o se già fossero presenti sul campo di battaglia – probabilmente è da immaginare la seconda ipotesi: i Romani, inferiori in numero, potrebbero aver tenuto questa riserva nel timore di essere circondati, come stava per accadere.
Questo è in realtà l’unico accenno vero e proprio allo svolgimento dello scontro dal punto di vista tattico. Questo potrebbe indicare anche un effettivo svolgersi dello scontro senza particolari iniziative da una parte o dall’altra.
Il resto della narrazione di Ammiano, anche se forse infiorettato con alcuni topoi letterari, è uno spaccato dell’incredibile violenza delle battaglie nel periodo tardo antico.
Vale la pena riportare le parole dell’autore: “[…] ciascuno si scagliava con prontezza là dove lo schieramento era più compatto ed andava incontro alla morte sotto i colpi delle spade e dei dardi che, come la grandine, cadevano d’ogni parte.
La cavalleria inseguiva da ogni lato i fuggiaschi e con grande vigore li colpiva alla nuca ed alle spalle, così pure da entrambe le parti i fanti tagliavano i garretti a quanti cadevano ed erano impacciati per la paura.
Tutta la zona era coperta di cadaveri; giacevano fra questi alcuni moribondi, che nutrivano una vana speranza di salvarsi, altri erano stati colpiti da pietre lanciate da fionde oppure da aste fornite di punte di ferro, mentre ad altri, infine, le teste erano state spaccate da un fendente dalla sommità attraverso la parte centrale della fronte e pendevano, con un orrendo spettacolo, su una e sull’altra spalla.”
Secondo Ammiano, lo scontro andò avanti con tremenda violenza fino al calar della notte. Quando si fece buio, “i sopravvissuti rientrarono piuttosto tristi negli accampamenti.”
Nessuno dei due eserciti aveva prevalso sul campo. La sanguinosa battaglia dei Salici si era risolta in un pareggio, con perdite considerevoli (anche in questo caso, impossibili da stimare) da entrambe le parti.
I due eserciti dovevano essere davvero esausti, poiché si limitarono a recuperare e seppellire soltanto gli ufficiali di alto rango, lasciando guerrieri e soldati sul terreno. Ancora ai tempi in cui Ammiano scriveva, circa quindici anni più tardi, i campi erano “disseminati di ossa biancheggianti”.
I Romani, inferiori di numero, avevano subito numerose perdite, probabilmente anche complice il temporaneo sfondamento dell’ala sinistra. Tuttavia, il lunghissimo combattimento aveva permesso all’esercito imperiale di infliggere grandi danni all’esercito dei Goti.
I Romani avevano combattuto così duramente, e i Goti avevano subito tali perdite, che questi ultimi per sette giorni si rifiutarono di uscire nuovamente dal carrago, nonostante i Romani si fossero nel frattempo ritirati verso Marcianopoli.
Da ad Salices alla fine della guerra
Dopo l’inconcludente e sanguinosa battaglia dei Salici, approfittando della temporanea inoperosità dei Goti, i Romani tornarono al loro piano originario – ovvero chiudere i passi montani del massiccio dell’Emo, per assediare i Goti nel territorio tra i Balcani e il Danubio, per finirli per fame.
Ricomere tornò in Gallia. Sarebbe tornato in Tracia l’anno successivo con nuove truppe da Occidente, partecipando poi alla fatale battaglia di Adrianopoli.
Mentre di Profuturo non sappiamo più nulla dopo ad Salices, il che può far supporre che sia morto durante lo scontro, Traiano sappiamo che fu convocato a Costantinopoli da Valente, per rispondere proprio delle ingenti perdite avute nella battaglia.
Traiano se la cavò e partecipò alle future operazioni, però solo per finire ucciso nella battaglia di Adrianopoli.
Quando Valente passò il comando delle truppe in Tracia a Saturnino, questi senza vere motivazioni valide sbloccò i passi montani per radunare le forze, permettendo così ai Goti (che nel mentre si erano alleati con i loro nemici ancestrali, gli Unni e gli Alani, che passarono il Danubio) di tornare in Tracia.
I Goti ripresero immediatamente i saccheggi e le devastazioni, e fu nuovamente impossibile fermarli.
Nonostante una breve riscossa romana grazie all’esperto magister peditum Sebastiano, la guerra subì un punto di svolta cruciale nell’agosto del 378. Nella battaglia di Adrianopoli l’esercito romano d’Oriente finì annientato dai Goti, e lo stesso imperatore cadde ucciso.
[Leggi anche Sebastiano, flagello dei Goti]
La guerra sarebbe finita solo nel 382, quando Teodosio, dopo aver rimesso in piedi energicamente l’esercito d’Oriente con misure straordinarie e aver proseguito la guerra senza però ottenere successi decisivi, fu costretto a negoziare un trattato di pace con i Goti – molti dei quali furono anche arruolati tra le sue file.
Iniziava un periodo nuovo e turbolento per l’impero romano.
La battaglia dei Salici è uno scontro davvero paradigmatico di questa cruciale guerra dell’impero romano: sanguinosa, inconcludente, e infine svantaggiosa per i Romani, i quali per l’intero secolo successivo dovettero affrontare un “problema barbarico” sempre più pressante.
Bibliografia essenziale
Fonti antiche
Ammiano Marcellino, Le Storie
Studi moderni
A. Barbero 2010, Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell’impero romano.
A. Barbero 2012, 9 agosto 378. Il giorno dei barbari.
P. Heather 2008, La caduta dell’impero romano. Una nuova Storia.
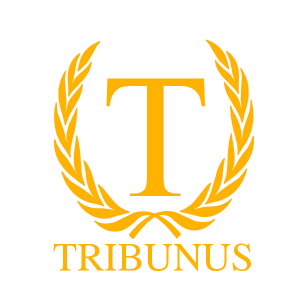






5 thoughts on “La battaglia dei Salici (377 d.C.)”