Nel corso di più scavi avvenuti nel XIX secolo in località Beligna (a sud di Aquileia), vennero scoperte, all’interno di una più vasta necropoli, sei sepolture femminili davvero particolari, databili ai primi decenni del II secolo d.C.
Queste tombe erano separate da qualunque altra sepoltura della necropoli, forse addirittura per mezzo di un recinto.
Come le altre defunte all’interno dell’area necropolare, le sei appartenenti a questo particolare gruppo non sembrano appartenere ad un ceto aristocratico, ma la loro vita parrebbe aver avuto modalità o eventi fuori dal comune, legati forse ad un ambiente religioso.

In una di queste sei sepolture, in particolare, vennero rinvenuti alcuni elementi di oreficeria, tra i quali le più celebri sono sicuramente le 203 appliques a forma di mosca ad ali chiuse, a grandezza naturale, realizzate in lamina d’oro sbalzata e oggi conservate ed esposte al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia.
La donna alla quale appartenevano le moschette, per via del suo ricco corredo, sembra aver avuto un ruolo di primo piano nel piccolo gruppo di sepolture.
Chi era la donna sepolta nella tomba “del corredo delle mosche d’oro”?
Per provare a rispondere a questa domanda, bisogna dare uno sguardo d’insieme a tutta la necropoli, peculiarmente legata a culti di tipo orientale.
Beligna e il culto di Beleno
Beligna, la località dove vennero rinvenute le sepolture in esame, è una zona dell’aquileiese così denominata per via della presenza di un santuario (o forse più di uno) dedicato in antico al dio Beleno.
Che nella zona vi fosse un culto dedicato a Beleno, divinità dai poteri sananti e salutiferi, è probabilmente confermato in primo luogo dalla presenza di acquee sulfuree. Beleno ebbe infatti un destino di morte, poi sconfitto secondo i percorsi della ierogenesi. In ciò si riscontrano dei nessi mistico-rituali con culti e miti di natura funeraria e legati all’acqua.
Il culto di Beleno in località Beligna è poi confermato anche da tutta una serie di ex voto epigrafici, rinvenuti nel 1548 attraverso azioni mirate a ricavare un dono prezioso e gradito da inviare a Venezia a Giovanni Grimani, neoeletto patriarca di Aquileia, noto per la sua passione per l’antichità.
Del dio si ricorda anche la valenza oracolare, che lo assimila ad Apollo, riscontrabile in un passo di Valerio Massimo che, sebbene tardo, parla di legami fra la divinità e l’aruspicina, nonché di divino numine, che fa supporre visioni oniriche. In tal senso, il dio era anche associato a Valetudo, espressione divina della salute fisica, legata ai responsi degli oracoli.
La zona, che sembra già collegata a culti particolari, come vedremo più avanti fu anche sede successivamente del culto di Iside e Serapide.
Inumazione e incinerazione
Dalla fine dell’età Flavia si assiste a un cambiamento della visione della morte, riportata verso un ambito di natura più intima: le architetture si ridimensionano e sembrano esser collocate in maniera libera, ma in realtà sono raggruppate secondo rapporti di parentela.
Inoltre, l’attenzione è rivolta quasi esclusivamente verso il defunto, del quale si cerca di trasmettere lo status sociale e la personalità attraverso il corredo.

La scelta del luogo, ma anche la peculiarità delle sepolture nella necropoli di Beligna, è indice di una scelta cosciente di quest’area da parte di individui, in questo caso donne, sensibili ad aspettative di natura escatologica, legate alla sfera misterico-salvifica.
[Leggi anche Le donne romane e la religione]
La modalità prediletta di deposizione, nella necropoli di Beligna, è l’inumazione: in bare in piombo (due delle quali appartenenti a deposizioni infantili non superiori ai tre anni), in casse lignee, in bare lignee rivestite in lastre di piombo, ecc.
Alcune defunte erano deposte su letti funerari in avorio, la cui sintassi decorativa sembrerebbe rimandare al ciclo dionisiaco, rappresentativo di una promessa di vita futura.
Per quanto riguarda gli speciali trattamenti di alcune delle salme, un parallelo si potrebbe trovare nelle città di Carnuntum e Aquincum, dove si hanno casi di cadaveri, legati alla cerchia isiaca, dissecati e avvolti in bende con resine, secondo un gusto egizio forse esportato proprio dalla città di Aquileia, dove queste pratiche erano ben note (anche se, a causa delle caratteristiche del terreno, se ne hanno scarse evidenze archeologiche).
Tuttavia, il particolare gruppo di defunte in esame, tra cui la stessa defunta della “tomba delle mosche d’oro” (la cui tomba era composta da un’urna lapidea, sigillata da grappe in ferro saldate poi a colatura di piombo), è stato invece cremato.
La scelta dell’incinerazione sembrerebbe inusuale in questo contesto, dato che solitamente risulta essere il rito dell’inumazione quello associato a corredi con oggetti legati o allusivi ad una sfera religiosa ben precisa.
Anche nella cerchia del culto isiaco sembrerebbe esserci una più attenta cura del corpo del defunto, che dovrebbe quindi venire sepolto e non cremato.
Tuttavia non mancano casi di incinerazione anche in questa cerchia, databili dal I secolo a.C. al II secolo d.C.
Il fatto che le sei particolari sepolture di Beligna fossero tutte raggruppate, e la particolarità dell’incinerazione, indica abbastanza chiaramente un qualche tipo di legame che univa questo specifico gruppo.
Il corredo
All’interno della necropoli di Beligna, particolarmente rilevante è la presenza di calzature del tipo a sandalo, questo soprattutto in ragione di alcuni tabù (come vedremo più avanti), e potrebbe connotare alcune delle donne come sacerdotesse.
Tra queste, anche la donna della “tomba delle mosche d’oro”.
I corredi della necropoli di Beligna, nel loro insieme, sembrano trovare dei punti di contatto con altre sepolture femminili, databili al II secolo d.C., ma ben attestate anche in età augustea e fino al III – IV secolo d.C., accomunate dalla presenza, diversificata e costante, di manufatti del corredo tali da configurare gli insiemi come rituali.
In essi compaiono elementi e accessori per capelli o per l’abbigliamento, strumenti di lavoro muliebre, manufatti argentei, specchi, profumi, gioielli ed amuleti aurei o realizzati con materiali carichi di valenze magiche come l’ambra ed il quarzo ialino.
La presenza nelle sepolture di oggetti in cristallo di rocca o in quarzo ialino sembrerebbe rimandare a credenze religiose e alla magia materiale. Il cristallo di rocca, in particolare, proveniva dall’Egitto, e Plinio lo annovera nei suoi scritti come “ghiaccio pietrificato” in grado di donare refrigerium al defunto.
Inoltre, le regioni alpine, nel periodo romano, sono state tra le maggiori produttrici di quarzo ialino.
Talvolta, tra i corredi si trovano anche delle pupae (bambole).
In questi contesti, il giocattolo (solitamente posto in sepolture infantili) potrebbe essere caricato di valenze simboliche. Ne è un importante parallelo il corredo della “dama di Callatis” (Mangalia, Romania), indentificata come una vera e propria sacerdotessa.
Anche la presenza di fusi e canocchie andrebbe forse letta in chiave religiosa, vedendo nell’arte di filatura e tessitura, lavoro vietato a uomini e vergini, un’allusione allo scorrere della vita.
La tomba “delle mosche d’oro” conservava un corredo prezioso e particolare, che oltre alle 203 moschette forate, in lamina d’oro, comprendeva: una collana di maglia sottile; un filo di perle; un pendente-amuleto cilindrico; un anello in argento con prasio; un cofanetto; una bottiglia e un cucchiaino; due fermagli a forma di foglie d’edera; e uno specchio in argento databile al I secolo d.C. o al successivo.
Le appliques a forma di mosca, e a forma di edera, non sembrerebbero rientrare nelle comuni codificazioni del mondo muliebre, anche se la scelta della raffigurazione di questo insetto sicuramente non è affatto casuale.
La scelta è probabilmente determinata dalla magia materiale, secondo cui il soggetto raffigurato viene caricato di forti valenze apotropaiche attive proprio contro l’essere che riproduce. Di particolare rilevanza è anche la resa enfatizzata degli occhi, che rimanda agli ofef, amuleti egizi attivi sulle mosche.
In quanto all’uso, queste appliques andrebbero riferite alla decorazione di un capo di vestiario, secondo la tradizione orientale (tunica segmentata).

Altri elementi potrebbero confermare il rapporto con il mondo egizio.
In particolare, la presenza del ciondolo-amuleto cilindrico, a sospensione verticale, destinato a contenere al suo interno sostanze o oggetti di carattere filatterico.
Questi oggetti si trovano anche in ambito greco-romano, dove però presentano solitamente una sospensione orizzontale, sul lato lungo del cilindretto. Quello della tomba aquileiese è invece da ascrivere, per la sua morfologia, alla tradizione egizia o fenicio-punica.

Richiama l’Egitto anche lo specchio in argento, metallo tradizionalmente legato alle divinità lunari. Questo oggetto è menzionato anche nei rituali isiaci del Navigium: alcune devote precedevano la statua della divinità, e sulle spalle portavano degli specchi.
In ambito isiaco, gli specchi potevano quindi costituire dei veri e propri oggetti di venerazione rituale.
[Leggi anche I Romani e il culto di Iside]
Moschette o cicale?
Nonostante siano sempre state classificate come “moschette”, quelle rappresentate nelle appliques non è improbabile ritenere, a mio avviso, che potrebbero essere altri insetti. Nello specifico, le “moschette” potrebbero infatti anche essere apette o, più probabilmente, cicale.
Tanto le api quanto le cicale hanno connotazioni e significati positivi.
La cicala, in particolare, è da sempre considerata simbolo di rinascita (allo stato larvale, l’insetto si nasconde sotto il terreno, per poi in età adulta uscire allo scoperto), promessa di una vita eterna, mentre per il suo canto è legata alla spensieratezza della gioventù.
Molti oggetti a forma di cicala, inoltre, sono stati rinvenuti su capi di abbigliamento di giovani fanciulle e bambini, anche in questi casi con una funzione apotropaica.

Per il suo canto instancabile durante i mesi della calura estiva, questo insetto era anche associato alle Muse e ad Apollo.
Le dimensioni degli oggetti ritrovati, però, spesso hanno creato confusione, confondendo appunto le cicale per api, mosche, o vespe. Ma non va trascurato che le cicale di grandi dimensioni sono tipiche solo di alcune zone dell’Europa Mediterranea, mentre nell’Est e nell’ Europa Centrale (luoghi in cui questa raffigurazione ha avuto molto successo) queste hanno solitamente delle dimensioni ridotte.
Per quanto riguarda la quantità, si potrebbe forse trovare un paragone, per quanto davvero molto tardo, con le 300 cicale d’oro rinvenute nel XVII secolo nella tomba del re franco, Childerico, anche all’epoca classificate come api.
Un equivoco che ritornerà nella storia di Francia: lo stesso Napoleone, durante la cerimonia di incoronazione, indosserà delle piccole api dorate, per emulare il re franco.
Solo con l’avvento del Cristianesimo, le cicale, considerate troppo pagane, verranno man mano sostituite, tra il V ed il VI secolo, da altri animali come gli uccelli.
Aquileia e il culto di Iside
Nella zona di Beligna, come abbiamo già visto legata al culto di Beleno, è stata individuata anche la presenza di un complesso sacro ad Iside e Serapide. Inoltre, nell’area a nord/nord-ovest di Aquileia vi sono tracce di un culto di Iside/Fortuna.
Le attestazioni del culto della dea egizia ad Aquileia sono riscontrabili anche in una serie di bronzetti, sia di provenienza orientale sia di ambito propriamente romano. Le statuette confermano in maniera inequivocabile la presenza di un culto attribuito ad Isis Lactans.

Questi bronzetti provengono, per la maggior parte, da piccoli ninfei e sacelli di domus della zona. Ciò dimostra l’importanza che il culto della dea, e di altre divinità egizie a lei collegate (Horus, Osiride, Anubi, Bes), avessero acquisito nel mondo e nella quotidianità romana, specie tra le donne.
All’epoca romana risalgono addirittura dei sistri, strumenti idiofoni, la cui datazione oscilla tra il I secolo a.C. e il successivo, tutti prodotti in Egitto da manodopera specializzata. Questo istrumentum era essenziale per la venerazione e il culto. Spesso alcuni riportano la raffigurazione del dio Bes o di Hathor.
La figura del dio Bes è parte integrante del corteggio di Iside e dei rituali svolti nei santuari.
Bes è il dio della musica, quale elemento di fascinazione che introduce in una dimensione oscura ed ignota, come quella della morte, come ben si evince da alcune raffigurazioni in ambito funerario ai quali dona prospettive di resurrezione.
Allo stesso tempo è ricordato anche come divinità che propizia e protegge le gravidanze. Alcune figurine di terracotta con l’immagine del dio, infatti, erano poste sul ventre delle donne durante il travaglio a salvaguardia della salute e della maternità.
Di particolare rilevanza è un altro bronzetto che mostra la dea Iside in atto di agitare il sistro. Questa statuetta mostra la divinità con un’acconciatura tipicamente libica, coperta da un ampio mantello da bordi frangiati, che si chiude sul petto con un particolare nodo: un costume tipico delle devote.
Nella mano destra stringe lo strumento, e il braccio è proteso in alto e in avanti, proprio come facevano le sacerdotesse o i fedeli. Il sistro è raffigurato con dovizia di particolari, tanto che nella parte alta tondeggiante si può distinguere anche la figurina di Bastet, in atto di allattare, oppure un basileion, ossia un disco solare sostenuto da due spighe e sormontato da piume.

Tuttavia, quelli appena elencati sono tutti oggetti di dimensioni e fattura abbastanza modeste.
Di tutt’altro formato e gusto sono, invece, i due reperti scultorei (di provenienza ignota, conservati nei magazzini del MAN di Aquileia) raffiguranti dei piedi, con molta probabilità appartenenti ad una statua di Iside, che proprio per via della loro maestosità sembrano uscire dall’ambito privato.

Essi presentano una fattura elegante ed attenta alla resa dell’anatomia. La tipologia delle calzature indossate, costituita da un sandalo con strisce che si incrociano fra l’alluce ed il secondo dito, fermato in cima da un prezioso fermaglio a forma di foglia d’edera, rimandano a scarpe tipica della moda egizia.
La nudità del piede, inoltre, fa supporre che la figura rappresentata fosse proprio una divinità, dato che anche questo era carico di sacralità e non poteva esser mostrato in pubblico, fatta eccezione per le sacerdotesse di alcuni culti o particolari momenti religiosi.
Proprio la foglia d’edera trova un riscontro reale nel corredo “delle mosche d’oro”.

L’identità delle sepolture di Beligna: un problema ancora irrisolto
Pur avendo esaminato tutti gli aspetti più importanti legati alle tombe di Beligna, rimane difficile stabilire con sicurezza non solo chi fosse la donna sepolta nella “tomba delle mosche d’oro”, ma in generale l’identità delle inumate dell’intera necropoli.
Molto probabilmente, il legame che univa le donne ivi sepolte era di carattere religioso, connesso in particolare a un qualche tipo di culto di origine orientale, di tipo misterico ed escatologico, come poteva essere quello isiaco.
Pare assodato almeno che la defunta del corredo “delle mosche d’oro” avesse un ruolo di rilievo all’interno del suo gruppo, vista la presenza di simboli particolari assenti in altre tombe – ovvero le moschette (o cicale), elemento unico solo alla sua sepoltura, e l’edera.
Allo stato attuale della ricerca, di più è difficile dire. Tra le altre cose, essendo stata cremata, è impossibile stabilire la provenienza della defunta. Un’eventuale origine egiziana o nordafricana della donna resta infatti una speculazione, anche se non vanno trascurati i legami politici, economici e culturali tra Aquileia e l’Egitto.
Soltanto l’avanzamento delle ricerche e una comparazione puntuale con sepolture aventi elementi similari a quelle di Beligna (come la famosa sepoltura di Crepereia, rinvenuta a Roma) potrà portare maggiore luce sulla questione.
Bibliografia
R. Achtziger e U. Nigmann 2002, Zikaden in Mythologie, Kunst und Folklore in Römischer Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit , pp. 2 – 14
A. Giovannini 1996, Corredi funebri da tombe ad incinerazione di Aquileia, località Beliuna in Quaderni Friulani di Archeologia VI, pp. 41 – 46
A. Giovannini 2001, Riflessioni sui culti di salvezza ad Aquileia: la presenza di Iside in Orizzonti del sacro. Culti e santuari antichi in Altino e nel Veneto orientale, pp. 289 – 304
A. Giovannini 2002, Bronzetti isiaci dal Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, in Antichità Altoadriatiche, pp. 227 – 251
A. Giovannini 2005, Divinità femminili ad Aquileia. Spunti di ricerca sulla presenza di Iside da reperti scultorei e corredi funebri in Histria Antiqua XIII, pp. 377- 387
A. Giovannini 2018, “In contrada Beligna… acqua sulfurea”. La presenza ad Aquileia di acque termali tra antico e moderno in Antichità Altoadriatiche LXXXVIII, pp. 363 – 385
A. Giovannini, Spunti di riflessione su alcuni aspetti del culto di Beleno e di Antinoo. Divinità salvifiche ad Aquileia. Evidenza archeologiche e modalità religiose, pp. 157 -170
A. Giovannini, Moda, costume, e bellezza nell’Italia Antica. Moda maschile e femminile in Aquileia romana e altomedievale
E. Kysela 2002, Zikaden als Schmuck- und Trachtbestandteil in Römischer Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit, pp. 21- 26
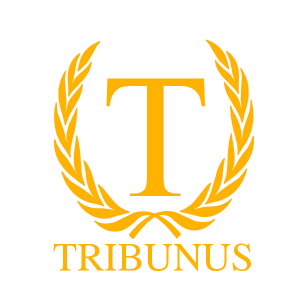
2 thoughts on “L’enigmatica “Tomba delle mosche d’oro” da Beligna (Aquileia)”