
Nell’immaginario collettivo i Galli hanno sempre rappresentato i nemici di Roma per antonomasia.
I Galli sono i feroci guerrieri di Brenno che saccheggiano Roma e pongono sotto assedio il Campidoglio, Vercingetorige e gli insorgenti di Alesia, oppure ancora, senza scomodare esempi illustri nella storia antica, gli irriducibili abitanti del villaggio armoricano partorito dalla fervida fantasia di Goscinny e Uderzo.
In realtà, complice l’endemica frammentazione politica presente addirittura all’interno delle stesse singole entità protostatali del mondo celtico, l’approccio dei Galli nei confronti della potenza romana fu tutt’altro che univoco, e se l’atteggiamento di determinate comunità va a confermare un ruolo antagonista per eccellenza, quello di altre si mosse su direttrici assai più collaborative.
È al 231 a.C. che viene fatto risalire il primo foedus (trattato di alleanza) tra la Repubblica Romana e i Galli Cenomani, la nazione celtica stanziata indicativamente nell’area tra il Chiese e l’Adige, e della quale i Romani ricercano l’amicizia per reazione ai preparativi militari delle altre grandi realtà galliche della Cisalpina, intente a pianificare la grande spedizione in Etruria del 225 a.C.1
Se i Cenomani non combatteranno direttamente a Talamone al fianco dei Romani, saranno insieme ai Veneti e agli Umbri autori di operazioni di disturbo e scorrerie nelle terre dei Boii, col preciso intento di frammentare le forze confederate delle altre popolazioni galliche, impegnandole su più fronti.2

Durante la spedizione romana del 223 a.C. in Cisalpina, le forze dei Cenomani invece si uniranno direttamente a quelle romane per dare battaglia ai Galli Insubri sul Chiese, e se il console Flaminio, a comando dell’esercito romano, mostrerà di non riporre eccessiva fiducia negli alleati, tagliandoli fuori dallo scontro vero e proprio3, questa rimane in ogni caso la prima attestazione di una collaborazione militare diretta tra Romani e Celti.
Conviene ricordare comunque che questi primi casi di collaborazione vedono le forze galliche presenziare come comprimarie a pieno titolo, forze alleate ma indipendenti e non subordinate; d’altra parte prima della riforma augustea il confine tra forze alleate, mercenarie e propriamente ausiliare all’interno dell’esercito romano appare labile e di difficile definizione, con un’autonomia di manovra dei contingenti stranieri che è riflesso dell’autonomia politica della nazione di provenienza.
La prima volta che viene utilizzato espressamente il termine “ausiliari” in riferimento a delle forze galliche in seno alla macchina bellica romana, questo accade in circostanze poco felici inerenti alla Seconda Guerra Punica, nel 218 a.C. subito dopo la sconfitta romana del Ticino, quando duemila fanti e duecento cavalieri celtici disertano e massacrano parte del contingente romano a cui erano accorpati, per poi unirsi alle forze annibaliche.
L’episodio viene riportato tanto da Livio4 quanto da Polibio5, e se il primo si limita a trascrivere brevemente il fatto, il secondo -con tutta probabilità la fonte primaria- fornisce dei dati interessanti, utili a comprendere la struttura dei primi corpi di ausiliari gallici della Repubblica.
Polibio infatti lascia presupporre che gli ausiliari gallici occupassero un’area propria circoscritta all’interno del castrum, l’accampamento fortificato romano, e tutta la dinamica dell’evento esclude il fatto che le forze galliche rispondessero o fossero gestite da ufficiali romani:
“I contingenti celtici all’interno dell’esercito romano […], si erano accordati gli uni con gli altri, e mentre rimanevano tutti silenziosi all’interno delle loro tende, attendevano un’opportunità favorevole per attaccare i Romani.
Tutti nell’accampamento fortificato avevano consumato la cena e si erano ritirati per riposare, e i Celti, lasciando passare la maggior parte della notte, all’alba si armarono e si abbatterono su quei Romani che erano accampati più vicino a loro.”
La nazionalità degli ausiliari ribelli non viene specificata in nessuna delle due fonti, ma il fatto che Livio in seguito, trattando della battaglia della Trebbia, citi espressamente la presenza nello schieramento romano di ausiliari Cenomani, indicandoli come l’unica gente gallica rimasta fedele6, porta a supporre che si trattasse di corpi forniti da Insubri, Boii e Lingoni, nazioni galliche di recente sottomissione, che nonostante ciò già dovevano fornire contingenti di supporto ai Romani.
L’esercito romano, per quanto probabilmente già all’epoca delle Guerre Puniche deteneva il primato dell’esercito di popolo con la miglior fanteria di tutta l’Europa antica, ha sempre fortemente accusato la carenza di una cavalleria efficiente, tant’è che i pochi successi dei cavalieri romani in battaglia hanno avuto luogo quando quest’ultimi abbandonavano le cavalcature e combattevano a piedi.7
La necessità di supplire a tale carenza portò Roma ad attingere a piene mani a reparti di cavalleria forniti dai popoli alleati o sottomessi, e se certamente una cavalleria d’eccellenza appare fornita da alcuni dei socii italici dell’Italia meridionale, questa non poteva bastare a colmare la necessità di truppe montate dell’intera macchina bellica romana.

I Galli, se mostravano di avere delle fanterie scarsamente addestrate e poco affidabili, come si riflette dalla rotta immediata degli ausiliari Cenomani davanti ai pochi elefanti di Annibale alla Trebbia8, avevano piuttosto la fama di ottimi cavalieri, e questo porta i Romani a farne ampio utilizzo, anche quando la loro fedeltà ed il loro attaccamento alla causa romana è questionabile.
La presenza di corpi di fanteria ausiliaria celtica tra le schiere romane durante la Seconda Guerra Punica appare più che altro dettata dalla necessità contingente più che da una consuetudine radicata, ed infatti tutte le testimonianze successive che parlano di ausiliari gallici fanno riferimento quasi esclusivamente a corpi di cavalleria.
Le uniche eccezioni in tal senso si manifestano in contesti altrettanto straordinari, quali la Guerra Sociale9, che vede corpi di fanteria gallica impiegati tanto dai Romani quanto dai ribelli italici, e la guerra civile tra Cesare e Pompeo, che vede il reclutamento da parte di Cesare di arcieri ausiliari gallici della nazione dei Ruteni.10
Entrambi i casi si presentano in momenti di crisi eccezionale, e se l’impiego di fanti ausiliari gallici durante la Guerra Sociale da parte di Roma riflette l’impossibilità di appoggiarsi alle abituali reclute dei socii italici, appunto in rivolta, per quanto riguarda gli arcieri Ruteni di Cesare, più che ad un reale interesse nel costituire reparti etnici di sagittarii gallici, mancando una qualche tradizione arcieristica celtica riconosciuta ed apprezzata dai Romani come nel caso dei Siriani o dei Cretesi, si dovrebbe ricondurre il gesto all’impellente necessità di usufruire di truppe di supporto equipaggiate con armi da tiro senza poter attingere alle solite sorgenti di reclutamento come Creta o il Medio Oriente.
Al contrario, nell’evidente interesse romano per i corpi di cavalleria celtica si trova il riflesso di quel perfezionamento dell’equipaggiamento militare gallico volto ad una specializzazione nell’ambito equestre, che si realizza appieno durante il II secolo a.C.
L’eccellenza dei cavalieri celtici viene rilevata apertamente dagli autori classici, e Strabone si spinge ad affermare che le migliori truppe di cavalleria dei Romani sono reclutate proprio tra i Celti.11
Cavalieri ausiliari gallici appaiono sotto il comando di Lucullo alla battaglia di Tigranocerta del 69 a.C. durante la Terza Guerra Mitridatica12, poi ancora sotto il comando di Crasso durante la sua disastrosa campagna contro i Parti13 del 53 a.C., ed infine cavalieri ausiliari gallici sono citati tra le forze che Aulo Gabinio, per ordine di Pompeo, mette a disposizione del monarca d’Egitto Tolemeo XIII.14
Se durante il III secolo a.C. il bacino di reclutamento di ausiliari gallici è senza ombra di dubbio limitato alla Cisalpina, con l’espandersi dell’egemonia romana, cavalleria ausiliaria viene arruolata anche in Gallia Transalpina.
All’indomani della campagna di conquista delle Gallie, Cesare recluterà circa quattromila unità di cavalieri ausiliari, sia presso la confederazione degli Edui, sia presso le nazioni galliche della Provenza15, e durante la prima spedizione in Britannia sarà accompagnato da cavalieri ausiliari della nazione belgica degli Atrebati.16
Tale sarà la dipendenza dall’apporto celtico in ambito equestre di Cesare che, venutogli a mancare come conseguenza della rivolta pangallica di Vercingetorige, dovrà supplirne reclutando truppe montate presso i Germani.17
La cavalleria ausiliaria gallica prese parte infine anche alle Guerre Civili, e se sappiamo di un reparto stanziato come guarnigione da Cesare a Turi, in Puglia, distintosi per la sua fedeltà18, Appiano accenna brevemente ad una guardia di cavalieri gallici come scorta del Cesaricida Giunio Bruto19, e ancora cavalieri gallici sono citati persino tra le truppe del re di Numidia Giuba, alleato di Pompeo.20

Illustrazione di Sean O’ Brogain.
Il massiccio impiego di ausiliari gallici porta con se la necessità di regolarizzarne ed inquadrarne il più possibile la posizione, e da Cesare riceviamo la preziosa informazione che alcuni reparti rispondevano direttamente agli ordini di decurioni romani.21
Se questo appare difficilmente plausibile per i cavalieri ausiliari forniti dagli Edui e dagli Atrebati all’epoca delle Guerre Galliche, non risultando ancora tra i popoli subordinati ma alleati e amici del popolo romano, appare invece assai probabile per i reparti reclutati presso le nazioni galliche sottomesse, sia per differente status giuridico, sia forse per via precauzionale.
Effettivamente, soprattutto a riguardo di corpi militari celtici di una certa importanza, appare evidente la volontà di ricondurli il più possibile all’interno della catena di comando dell’esercito romano propriamente detto, così da poterli gestire in maniera maggiormente lineare e sicura.
A tal proposito vi saranno alcuni casi celebri dove le leve celtiche verranno irreggimentate addirittura in qualità di legionari, scavalcando il ruolo ausiliario ed ottenendo di riflesso la cittadinanza romana.
Sarà il caso delle reclute transalpine alle quali Cesare attingerà per formare la Legio V Alaudae22, dal nome gallico dell’allodola in riferimento ai pennacchi piumati degli elmi, oppure i Galati armati e addestrati da Deiotaro alla maniera romana, che andarono a costituire la XXII Deiotariana.23
E bene però ricordare che questi rimangono comunque casi straordinari ed isolati, oltretutto specificamente riferiti a contingenti armati e addestrati secondo l’uso romano, dove al contrario l’ausiliario, per ruolo, è invece caratterizzato, perlomeno in epoca repubblicana, dal suo armamento etnico, ed è appunto reclutato per supplire con la sua esperienza in settori specifici a specifiche lacune dell’esercito romano.
Se la pratica di porre ufficiali romani a comando dei reparti di cavalleria ausiliaria gallica doveva probabilmente essere diventata frequente alla conclusione delle Guerre Galliche, il sistema organizzativo e gestionale interno degli ausiliari appare ancora sovrapponibile a quello precedente degli eserciti delle nazioni celtiche indipendenti.
Lo spostamento di un numero considerevole di armati necessita di un apparato logistico che ne soddisfi le necessità, e questo, mutuato direttamente dal modello migratorio arcaico, è caratterizzato dalla cospicua presenza di carriaggi e salmerie in seno all’esercito, che sebbene ne condizionino gli spostamenti risultano indispensabili per il trasporto del materiale di supporto.
La logistica appare dunque ancora acerba e terribilmente confusionaria se paragonata a quella delle legioni; Cesare riporta che i suoi stessi ausiliari gallici si muovono “con molti carri e grandi bagagli, come l’uso gallico richiede”, e prosegue dipingendo un quadro che agli occhi metodici di un generale romano non può che apparire caotico e che riflette perfettamente la struttura clientelare gallica che era alla base del reclutamento:
“Vi erano inoltre circa seimila uomini di ogni categoria sociale con i servi e i figli; ma nessun ordine, nessun comando sicuro vi era, ciascuno agiva secondo il proprio giudizio e tutti procedevano senza timore, senza disciplina…“24.
Se ci appoggiamo all’analisi comparata di altre fonti che descrivono l’organizzazione degli eserciti gallici in movimento, possiamo desumere inoltre anche un’importante presenza femminile in seno alle truppe in marcia, il cui compito, oltre ad essere molto probabilmente quello di gestire il materiale di supporto, in particolare le derrate alimentari, secondo una tradizione evidentemente arcaica aveva la funzione di dirimere le cause e i litigi che potevano scoppiare tra i guerrieri.25
Così come per la struttura organizzativa, anche la panoplia degli ausiliari gallici e il loro approccio allo scontro appare frutto del loro retaggio culturale, e per identificarlo con sicurezza conviene incrociare tanto le fonti letterarie che quelle archeologiche.
Plutarco, nella Vita di Crasso, scrivendo dell’armamento dei cavalieri ausiliari gallici a Carre, delinea dei combattenti “equipaggiati in maniera leggera e dai corpi non protetti [da armature]” che brandiscono “lance piccole e leggere”, con ogni probabilità dei giavellotti.
Eppure a Carre i cavalieri gallici si mostravano tanto versatili da “operare prodezze”: constatata l’inefficacia dei loro giavellotti contro le pesanti armature dei catafratti, “afferravano le lunghe lance dei Parti, strattonandole insieme agli uomini [che le impugnavano], tirandoli giù da cavallo”, oppure “abbandonavano le loro stesse cavalcature, e insinuandosi sotto quelle del nemico, le pugnalavano al ventre”.
Il costume occasionale di smontare da cavallo e combattere a piedi appare una pratica già riconosciuta nei cavalieri gallici ai tempi della Seconda Guerra Punica26, così come l’uso di giavellotti multipli fa parte di una tradizione antica che ha riscontro già nel IV secolo.27
Il quadro generale che se ne ricava è quello di una forza poliedrica, altamente mobile, equipaggiata per la schermaglia ma all’occorrenza, trasformandosi in forza appiedata, capace di un discreto potere d’arresto; l’ideale, come evidentemente intuiscono i Romani, da contrapporre all’approccio granitico ed univoco delle cavallerie pesanti catafratte delle popolazioni mediorientali.

La componente della schermaglia, in combinazione con l’uso massiccio di armi da getto, rimane comunque una delle caratteristiche principali, come si desume da quanto riportato da Arriano nell’Ars Tactica.
Dopo aver affermato che la maggior parte dei termini tecnici relativi all’ambito equestre in uso presso l’esercito romano “non appartengono alla lingua dei Romani, ma a quella dei Celti e degli Iberi, dato che i Romani adottarono queste tattiche che erano celtiche, poiché tenevano in grande considerazione la cavalleria celtica in battaglia”28, Arriano elenca il petrinos, ovvero l’arte di scagliare ripetutamente i giavellotti all’indietro, voltando le spalle al nemico durante la ritirata29, la xynema, ovvero la pratica di scagliare in rapida successione tre giavellotti poco prima di far scartare il cavallo30, e lo stolutegon, l’uso di sollevare, durante la fuga, lo scudo sopra la testa per poi volgerlo a protezione della schiena, piegando il braccio all’indietro.31
Se ricondurre il termine xynema alla lingua celtica appare difficile, gli altri due termini trovano i propri corrispettivi nel Gallese, con petrinos connesso a “pedrain”, che definisce i quarti posteriori del cavallo, e stolutegon a un composto di “ystle”, “ritirata”, e della radice “-teg ”, “copertura”.32
I riferimenti letterari alla panoplia degli ausiliari gallici la arricchiscono di un ulteriore elemento nella Vita di Lucullo, dove Plutarco fa un diretto riferimento all’uso della spada, utilizzata per scostare e parare le lunghe aste dei catafratti caucasici di Tigrane II alla battaglia di Tigranocerta.
Il conteso galloromano delle necropoli dell’area cenomane veronese, quali S. Maria di Zevio33, Casalandri di Isola Rizza34 e Madonna dell’Uva Secca di Povegliano, datate tra il II e il I secolo a.C., confermano la fonte letteraria, restituendo ricche panoplie che allo scudo, alle numerose cuspidi di armi in asta e ad alcuni elmi sommano numerosi esemplari di spade La Téne D, con lame che arrivando a superare i 90 centimetri, in alcuni casi con una larghezza massima di 4 centimetri, rispondono ad un modello che è evidentemente concepito per uso esclusivo dei combattenti a cavallo.
Al di la di teorici apporti delle genti germaniche, che andrebbero ricondotti in ogni caso ad una matrice originaria propria della cultura La Téne, è quindi nelle lame celtiche di ultima generazione che va ricercata l’origine della spatha romana, dalla quale a loro volta si svilupperanno le lunghe lame da cavalleria medioevali.
Se l’importanza degli ausiliari gallici relativa allo sviluppo tecnico e tattico equestre dell’esercito romano è innegabile, merita infine considerazione il loro ulteriore ruolo quali vettori della romanità in seno alle loro stesse comunità di provenienza.
Senza sminuire l’importanza della deduzione di colonie nelle province galliche quali centri successivi d’irradiazione della cultura classica, ancor prima gli ausiliari celtici ne saranno promotori, assimilandola durante la loro militanza al fianco delle legioni e diffondendola, così come avevano fatto nel proprio contesto con la cultura greca i Galli Senoni che avevano militato negli eserciti ellenistici e magnogreci.
La partecipazione celtica all’interno dell’organizzazione militare romana comportò naturalmente un inserimento sociale con notevoli ricadute in termini culturali, in quanto l’essere elementi attivi all’interno di un’organizzazione militare funzionale e forte, che per sua struttura e ruolo dipende dall’affidabilità e dalla integrazione delle forze in atto, comporta l’acquisizione di un bagaglio sociale ed una consapevole integrazione quale elemento essenziale non solo di partecipazione ma di letterale sopravvivenza.

Elementi culturali, abitudini di vita, pregi e difetti, nel particolare contesto di interdipendenza a livello di singoli e di gruppo, che si viene a creare in un esercito armi e in operazioni, vengono visti, vissuti, accettati e assimilati con una predisposizione e un’immediatezza difficilmente riscontrabile in altre situazioni sociali.
Il peso e la valenza di questi elementi postulano naturalmente il loro trapasso all’interno della struttura sociale familiare del primario gruppo di appartenenza, e quindi un indirizzo di assimilazione dell’intera cultura gallica ai principali valori sociali e culturali dell’organizzazione romana.
Bibliografia
Fonti
Appiano, Storia di Roma
Arriano, Ars Tactica
Cesare, De Bello Gallico
Cesare, De Bello Civili
Polibio, Storie
Senofonte, Elleniche
Strabone, Geografia
Svetonio, Vita di Cesare
Tito Livio, Ab Urbe Condita
Studi secondari
L. Salzani (a cura di) 1996, La necropoli gallica e romana di S. Maria di Zevio (VR)
L. Salzani (a cura di) 1998, La necropoli gallica di Casalandri a Isola Rizza (Verona)
W. J. Watson 1907-1908, Ancient Celtic Cavalry Terms, in The Celtic Review, vol. IV
_______________________
Note
[1] Polibio, Storie, II, 23
[2] Polibio, Storie, II, 24
[3] Polibio, Storie, II, 32
[4] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXI, 48
[5] Polibio, Storie, III, 67
[6] “auxilia praeterea Cenomanorum; ea sola in fide manserat Gallica gens”, Livio, Ab Urbe Condita XXI, 55
[7] Tito Livio, Ab Urbe Condita, II, 20
[8] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXI, 56
[9] Appiano, De Bellis Civilibus, I, 42; I, 50
[10] Cesare, De Bello Civili, 51
[11] Strabone, Geografia, IV, 4, 240
[12] Plutarco, Vite Parallele, Vita di Lucullo, 28
[13] Plutarco, Vite Parallele, Vita di Crasso, 25
[14] Cesare, De Bello Civili, III, 4
[15] Cesare, De Bello Gallico, I, 15
[16] Cesare, De Bello Gallico, IV, 35
[17] Cesare, De Bello Gallico, VII, 65
[18] Cesare, De Bello Civili, III, 22
[19] Appiano, Storia di Roma, De Bellis Civilibus, III, 97
[20] Cesare, De Bello Civili, II, 40
[21] Cesare, De Bello Gallico, I, 23
[22] Svetonio, Vita di Cesare, 24
[23] Cfr. Cicerone, Pro Rege Deiotaro
[24] Cesare, De Bello Civili, I, 51
[25] Polieno, Strategemata, VII, 50
[26] Polibio, Storie, III, 115
[27] Senofonte, Elleniche, VII, 1, 20-21
[28] Arriano, Ars Tactica, 33, 1. – Persino il termine in uso in epoca tardoromana per definire gli squadroni di cavalleria, drungus, parrebbe di origine gallica, come proposto da P. Rance, in Drungus, Δροῦγγος and Δρουγγιστί –a Gallicism and Continuity in Roman Cavalry Tactics, 2004, pp. 96-130
[29] Arriano, Ars Tactica, 37, 4
[30] Arriano, Ars Tactica, 42, 4
[31] Arriano, Ars Tactica, 43, 2
[32] W. J. Watson, Ancient Celtic Cavalry Terms, in The Celtic Review, vol. IV, 1907-1908 ,p. 384
[33] Cfr. L. Salzani (a cura di), La necropoli gallica e romana di S. Maria di Zevio (VR), SAP Società Archeologica S.r.l., 1996
[34] Cfr. L. Salzani (a cura di), La necropoli gallica di Casalandri a Isola Rizza (Verona), SAP Società Archeologica S.r.l., 1998
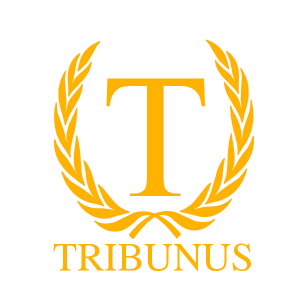


3 thoughts on “I Celti di Roma. Ausiliari gallici nelle legioni repubblicane ”