La disastrosa sconfitta nella battaglia di Dertosa aveva messo in seria difficoltà non soltanto la presenza cartaginese nella penisola iberica, ma anche l’intera campagna di Annibale in Italia.
Vista la posizione critica di Asdrubale, il Senato cartaginese fu costretto a inviare in Spagna un grande esercito – dodicimila fanti, millecinquecento cavalieri, venti elefanti, sessanta navi e una somma di mille talenti d’argento – che era stato predisposto e destinato alla campagna in Italia, sotto la guida di Magone Barca, fratello di Annibale e Asdrubale.
Mentre decideva di inviare Magone in Spagna invece che in Italia, il Senato cartaginese decise di aprire un ulteriore fronte di guerra, assegnando ad Asdrubale il Calvo (un omonimo del fratello di Annibale) una forza pari a quella di Magone e inviandola in Sardegna.
Sull’isola era infatti scoppiata la rivolta di Ampsicora, un ricco proprietario terriero filo-cartaginese che aveva sfruttato il sentimento antiromano che aleggiava in Sardegna, sia tra i sardo-punici che tra le popolazioni autoctone.
La rivolta di Ampsicora, tuttavia, ebbe breve durata. Dopo che il figlio Josto fu sconfitto e ucciso in uno scontro aperto con i Romani, Ampsicora, anche per non finire prigioniero dei Romani, si tolse la vita.

Roma agli sgoccioli: finanziare la guerra
Se per i Cartaginesi la situazione in Spagna era critica, alla fine dell’estate del 215 a.C. anche i Romani avevano i loro problemi da affrontare. Gneo e Publio Scipione inviarono lettere al Senato di Roma, nelle quali chiarivano le esigenze dell’esercito per poter proseguire la guerra con successo. Così ci scrive Livio: “[…] l’esercito desiderava denaro, vestiti, e grano, e che gli equipaggi desideravano qualunque cosa. Riguardo alla paga, [gli Scipioni] dissero che se l’erario fosse stato basso, avrebbero adottato un qualche piano grazie al avrebbero potuto procurarsela dagli Ispanici, ma che gli altri rifornimenti dovevano essere certamente inviati da Roma, poiché altrimenti né l’esercito si sarebbe potuto tenere insieme, né la provincia conservata.”
I senatori furono tutti d’accordo che le richieste degli Scipioni erano più che ragionevoli, ma che venire incontro ai due comandanti in terra iberica sarebbe stato molto complicato. Nel sostenere lo sforzo economico dettato dalla guerra, il Senato era preoccupato da un gran numero di fattori, che prosciugavano le finanze dello Stato o per le quali queste non potevano crescere allo stesso ritmo di prima: il gran numero di forze in quel momento dispiegate sui teatri bellici; la possibilità di dover pagare la costruzione di una flotta nel caso di un futuro attacco da parte dei Macedoni, alleati di Annibale; il fatto che persino Sicilia e Sardegna non erano quasi più in grado di sostenere le proprie guarnigioni per difendersi; il grande calo del numero di contribuenti che potevano sostenere lo sforzo bellico pagando le tasse (la maggior parte di questi era morta al Trasimeno e a Canne).
Il Senato era ben consapevole che non avrebbe potuto aumentare o imporre nuove tasse ai cittadini. Come sintetizza Livio: “[…] i pochi sopravvissuti, se fossero stati oppressi con ulteriori imposizioni, sarebbero morti per malanni di altro genere.”
Si rese necessario pensare a procedure non convenzionali, per poter finanziare almeno l’esercito di stanza in Spagna. Venne così stabilito che le forniture per l’esercito degli Scipioni fossero appaltate a dei privati, con la promessa che sarebbero stati i primi a essere risarciti una volta che l’erario lo avesse permesso.
Si fecero avanti tre “compagnie” (societates) di diciannove uomini ciascuna, che accettarono di prendersi carico dei rifornimenti a due condizioni: l’esonero dal servizio militare, e l’assicurazione da parte dello Stato che quest’ultimo si sarebbe preso totalmente carico delle eventuali perdite del materiale, a prescindere che fosse stato per una tempesta o per attacco nemico.
Il Senato accettò tutte le condizioni, e le tre societates si misero subito all’opera per rifornire l’esercito degli Scipioni, “con la massima fedeltà”.
Mentre finalmente la questione dei rifornimenti per i Romani era risolta, la guerra sul suolo iberico era destinata a riaccendersi. Quando finalmente iniziarono ad arrivare i rifornimenti per l’esercito e la flotta, gli Scipioni vennero a sapere che i Cartaginesi avevano messo sotto assedio la città di Iliturgi, che si era apertamente schierata dalla parte dei Romani.
L’assedio di Iliturgi
Iliturgi era un insediamento presso l’attuale Mengìbar, in Andalusia, più di cinquecento chilometri a sud dell’Ebro.
Nonostante fosse così distante dalle basi romane, gli Scipioni decisero attivamente di intervenire in aiuto della città, con un esercito di sedicimila uomini. I Romani si erano già spinti a sud dell’Ebro in almeno un’occasione (due, se diamo credito alla narrazione di Livio), nel 217 a.C., ma mai così lontano. La particolare situazione del momento, che vedeva gran parte delle popolazioni iberiche apertamente ostile a Cartagine, favoriva la decisione degli Scipioni.
Livio, anche in questo caso nostra unica fonte sugli eventi, non ci descrive nulla dei dettagli della spedizione e della marcia, entrando subito nel vivo degli scontri militari. La descrizione dello storico romano è molto frenetica e avvincente, come se tutto si stesse svolgendo nel giro di poche ore, ma dobbiamo probabilmente immaginare che tutte le operazioni siano avvenute nello spazio di alcuni giorni.
I Cartaginesi, forti di sessantamila uomini, erano divisi in tre accampamenti diversi, ognuno sotto la guida dei comandanti: Asdrubale, suo fratello Magone e Amilcare figlio di Bomilcare.
“Tra questi tre accampamenti del nemico, gli Scipioni effettuarono l’ingresso nella città dei loro alleati, dopo un violento scontro e un gran massacro dei loro avversari, e vi introdussero del grano, del quale vi era scarsità”: questa è la prima azione che riporta Livio.
Senza troppi indugi, gli Scipioni puntarono subito all’obiettivo più ambizioso: il campo maggiore cartaginese, dove stava lo stesso Asdrubale. Così Livio: “[…] e dopo aver esortato gli abitanti della città a difendere le loro mura con lo stesso spirito che avevano visto mostrato dall’esercito romano che stava combattendo per loro, [gli Scipioni] guidarono le loro truppe ad attaccare il più grande degli accampamenti, nel quale Asdrubale aveva il comando”.
Magone e Amilcare accorsero al campo principale, per riunire le forze con Asdrubale, e si schierarono a battaglia. A parte darci i numeri dei due eserciti, Livio non ci fornisce informazioni utili sulle formazioni e sulla composizione dei due schieramenti.
Livio ci dice solamente che i Romani, per quanto contro forze abbondantemente soverchianti, riuscirono a ottenere una schiacciante vittoria, uccidendo più di sedicimila nemici, e catturando più di tremila uomini, quasi mille cavalli, cinquantanove stendardi e sette elefanti (cinque, invece, erano stati abbattuti sul campo di battaglia).
Dopo la vittoria, i Romani poterono lasciare un presidio all’interno della città, attestandosi stabilmente anche così a sud dell’Ebro.

L’assedio di Intibili
Costretti a ritirarsi da Iliturgi dopo una così schiacciante sconfitta, i Cartaginesi posero sotto assedio l’insediamenti di Intibili, ben più a nord, presso l’ordierna Benicarlò – anche in questo caso, la narrazione di Livio procede molto veloce, senza darci indicazione del tempo trascorso; probabilmente, anche quest’azione avvenne alla fine dell’estate del 215 a.C.
I Cartaginesi riuscirono a reclutare diversi uomini dalla regione di Intibili, “massimamente avida di guerra”; diversi giovani, attirati anche dalla promessa di bottino e saccheggio, si unirono ad Asdrubale.
I Romani attaccarono i Cartaginesi, e la battaglia si risolse col medesimo esito della precedente. I Cartaginesi persero tremila uomini e oltre duemila finirono prigionieri, insieme a quarantadue stendardi e nove elefanti.
Con questa ulteriore vittoria, il teatro di guerra spagnolo si stava rivelando sempre più decisivo ai fini della guerra. Come commenta Livio: “Allora, davvero quasi tutte le popolazioni della Spagna passarono dalla parte dei Romani, e i successi in Spagna durante quell’estate furono molto più importanti che quelli in Italia”.

Bibliografia
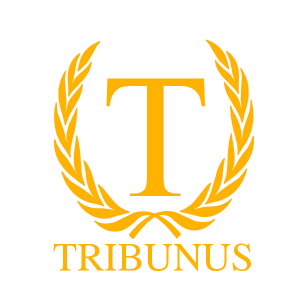
One thought on “La Seconda Guerra Punica in Spagna (4) – gli assedi di Iliturgi e Intibili (215 a.C.)”