Titolo: “Attila”
Titolo originale: “Attila. La violence nomade”
Anno pubblicazione: 2010
Editore: Salerno Editrice
“Attila” di Michel Rouche è uno di quei saggi come piacciono a me: completi, che cercano di entrare in profondità all’interno del mondo dei protagonisti delle vicende raccontate, e che affrontano gli argomenti e i temi centrali partendo da lontano, per permettere al lettore di avere una visione a tutto tondo di ciò di cui si sta parlando, e anche oltre l’argomento principale.
Il titolo del libro, senza il suo originario sottotitolo francese (“La violence nomade“), è ingannevole: su un volume di circa 300 pagine, Attila fa infatti la sua comparsa solo intorno a pagina 90, per uscire di scena un’ottantina di pagine dopo (vi rientrerà solo nel penultimo capitolo, “Attila dopo Attila”, dedicato alla persistenza, trasformazione e all’uso del personaggio del re unno e del suo mito tra Medioevo ed Età contemporanea).
Il lavoro del prof. Rouche è infatti molto più che un libro su Attila: è un grande viaggio temporale e geografico nel mondo di quei nomadi a cavallo che, a ondate successive e sovrapponendosi gli uni agli altri, dalle steppe dell’Asia centrale si affacciarono di volta in volta sul mondo occidentale, ed è una grande narrazione dell’incontro, ma soprattutto dello scontro e della totale incomprensione e inconciliabilità di questi due mondi.
Per cui, il primo breve capitolo è necessariamente dedicato allo spazio geografico della steppa, quello spazio gigantesco che dalla Siberia e gli Altaj a est, giunge sino al Danubio e all’Ungheria a ovest, una vastità di oltre 10.000 km nella quale sono nate tutte quelle civiltà nomadi che, sul dorso dei loro cavalli, sono giunte alle soglie del mondo mediterraneo. Un capitolo apparentemente solo di apertura ma fondamentale per capire diversi comportamenti e abitudini dei popoli che abitano la steppa e che in essa migrano e si spostano.
In seguito, sempre attraverso una breve trattazione (un capitolo chiamato molto saggiamente “Le nebulose tribali”, a indicare la fluidità dei popoli del Barbaricum), Rouche riesce a passare brevemente in rassegna i popoli nomadi e seminomadi che si susseguirono e in parte si sovrapposero dall’epoca classica fino al IV sec. nell’area tra il Don e il Danubio e le loro complesse etnogenesi: Sciti, Sarmati, Ostrogoti, Alani, solo per citare i principali (questi ultimi due assembramenti, in particolare, si potrebbero definire a pieno titolo i “protagonisti secondari” del libro, oggetto quasi della stessa attenzione riservata agli Unni).
Un altro breve capitolo sull’impero romano tra IV e V secolo, e si inizia a entrare nel vivo: dallo scontro di Adrianopoli tra Romani e Goti all’ascesa della potenza unna, con il dominio pressoché totale sui Germani orientali (escluse pochissime popolazioni, come i Longobardi), e si incontra finalmente quello che dovrebbe essere il protagonista dell’opera, Attila.
Un Attila affatto ridimensionato, né ingigantito, quello di Rouche, ma un ritratto il più possibile attinente alle fonti, costantemente citate, dalle quali emerge un uomo eccezionale, nel bene e nel male, anche per il mondo nomade, di quella “società di predatori”, come la definisce l’autore, del quale è il perfetto rappresentante, un vero archetipo del cavaliere della steppa. Un conquistatore e un dominatore, per nulla interessato a entrare a far parte della romanitas o a terreni da coltivare, come bene o male la maggior parte dei popoli germanici, solo semi-nomadi: il suo unico interesse è dominare quel mondo e ottenerne tutto il bene materiale che può ricavarne. I capitoli dedicati ad Attila sono un viaggio a spron battuto in quello scenario pazzesco che fu l’impero romano del V secolo, una narrazione alla quale, grazie anche alla prosa niente affatto pesante di Rouche, è impossibile resistere.
Come detto qualche riga sopra, Attila scompare dalla scena relativamente presto nel libro di Rouche, che però non termina con la morte del condottiero unno.
Il libro infatti prosegue con quella che si può solo definire come un’analisi antropologica del mondo unno e delle steppe in generale, dal quale si apprendono ancora di più l’inconciliabilità tra questo mondo e quello sedentario-agricolo-mediterraneo.
La narrazione delle vicende storiche infine riprende, con la disgregazione totale del dominio unno in pochi anni dopo la morte di Attila e l’arrivo di (almeno) altri due popoli nomadi alle soglie del Danubio e del Reno nei secoli successivi al V, che in parte si stratificano con le culture nomadi precedenti (anche nella memoria dei cronachisti occidentali che ce ne lasciano memoria, davvero incapace di distinguere un popolo nomade da un altro) e in parte sono portatori di elementi del tutto nuovi, pur permanendo di fatto nel loro ruolo di “società di predatori”: gli Avari prima, e i Magiari poi (e giusto un breve accenno ai Bulgari). L’autore riconosce e cita anche diversi altri popoli nomadi che da est continuano a spostarsi verso ovest (es. Cazari, Peceneghi e, seppur non li cita, i Mongoli), ma sceglie di fermarsi ai Magiari poiché sono gli ultimi che mandano nel panico il mondo europeo occidentale che arriva fino a Reno e Danubio, con le loro incursioni improvvise e con le loro tattiche praticamente incontrastabili per gli europei dell’epoca.
Un altro grande pregio del libro di Rouche è costituito dai continui riferimenti all’ambito archeologico, con reperti descritti nei dettagli che avvalorano e aiutano a rendere più “vive” le parole dell’autore.
Certo, il libro non è esente da pecche, che seppure non mi abbiano infastidito particolarmente nella lettura, vorrei far notare. Come ad esempio la tendenza a rimarcare una sorta di separazione più che amministrativa tra Oriente e Occidente, e la tendenza a chiamare spesso “Greci” gli abitanti della pars Orientis; oppure, il fatto di dover spesso virgolettare l’aggettivo “romani” quando messo di fianco a nomi di generali di probabile ascendenza barbarica (e si parla di comandanti veri e propri, quasi sicuramente anche cittadini romani, non comandanti solo de jure). È poi da segnalare uno strafalcione la cui presenza è poco spiegabile, sul fatto che l’imperatore Maggioriano sia stato assassinato dagli Alani, e questo assassinio sarebbe stato vendicato da Ricimero: questo non è possibile, visto che tutte le fonti concordano che sia stato proprio Ricimero a far assassinare Maggioriano! Da ultima, da segnalare quella che non è altro che una svista: in un passaggio dove è brevemente raccontato il famoso episodio di Alboino e della coppa dalla quale viene fatta bere la sposa Rosmunda, Alboino è indicato come re dei Gepidi. Solo una svista, come detto, poiché diverse pagine dopo si ritorna sul fatto, raccontato però in modo corretto.
A prescindere da questi pochi difetti, l’opera è assolutamente imperdibile a mio parere. La lettura è molto scorrevole, con continui rimandi anche ad argomenti già esposti, il che facilita ulteriormente la lettura, e il libro si legge quasi d’un fiato.
Da ultimo, da segnalare che le ultime pagine sono corredate da un’ampia sezione (quasi quaranta pagine) con gli estratti in traduzione delle fonti scritte utilizzate, una tabella cronologica nella quale sono segnati gli eventi relativi all’impero, ai popoli delle steppe e ai popoli germanici (il che è di grande aiuto nel districarsi tra gli innumerevoli fatti raccontati nel corso del libro), quattordici mappe e una serie di utili alberi genealogici di sovrani unni, germanici e romani.
“Attila” di Rouche è un libro che non può non appassionare e dopo la sua lettura, per quanto possiate non amare particolarmente né Attila né i popoli della steppa (come il sottoscritto), non potrete fare a meno di rispettarli e di rimanerne tremendamente affascinati.
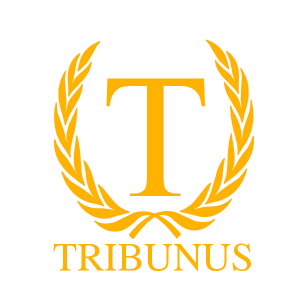


Sembra molto interessante, se ho capito bene offre una visione unitaria delle migrazioni dei popoli della steppa, cosa che apprezzo perchè ci si dimentica spesso che le invasioni barbariche e nomadiche proseguirono almeno fino all’anno mille. Una domanda: lo sviluppo tecnologico di questi popoli è approfondito? Mi riferisco ad esempio alla staffa o all’arco composito.
LikeLike
Sì, c’è un capitolo intitolato “La superiorità militare degli Unni” dove vengono trattati anche questi aspetti, oltre al modo di combattere (per i Romani non del tutto inedito, visti gli scontri passati con i Parti, ma sicuramente inusuale e con alcune novità, come l’uso di un “lazo”). Sulla staffa, l’autore è giustamente molto cauto, anche se sembra sposare la tesi che gli Unni avessero in dotazione una “protostaffa” in cuoio o legno, derivata dai modelli cinesi di III-IV sec.
LikeLiked by 1 person