Fino ai tempi di Leone VI (886 – 912), solo gli imperatori e la propria famiglia avevano il diritto di essere seppelliti in splendidi sarcofagi in porfido all’interno delle mura cittadine.
La gente comune veniva sepolta in cimiteri, situati fuori le città. Le tombe erano contrassegnate da lapidi con sopra inciso solo il nome del defunto e l’occupazione, seguito dagli auguri dei parenti.
I motivi per limitare le sepolture nelle città erano dettati dalla tradizione romana antica, o forse anche da ragione igieniche e di spazio.

Il testamento
Il diritto romano, nel corso dei secoli, affinò tutta una serie di normative e leggi riguardanti il testamento: potevano farlo solo le persone libere, che fossero sui iuris (i.e. che godesse di pieni diritti come cittadino), e che avessero raggiunto l’età adulta.
Di conseguenza, erano esclusi i malati mentali e coloro che si trovavano prigionieri in mano nemica – questi ultimi, a meno che non avessero redatto il testamento prima della reclusione: in tal caso era da considerarsi valido.
Oltre a questi casi, ben presto, col nuovo clima religioso anche altre categorie si aggiunsero alla lista di coloro che non potevano fare testamento: gli eretici, gli apostati, i pagani. A questi, in particolare, venne anche proibito di ricevere lasciti o eredità.
L’atto formale per testare prevedeva la presenza di ben sette testimoni, che avrebbero dovuto sottoscrivere il testamento e apporre un sigillo. Poteva tuttavia anche esser sufficiente una dichiarazione orale, resa ugualmente davanti a sette testimoni.
Nelle campagne solitamente, il numero dei testimoni scendeva a cinque, dato che l’alfabetizzazione era meno diffusa. C’era però l’obbligo di metter al corrente i testimoni sui chi fossero gli eredi designati.
Leggi anche La vita nelle campagne nel periodo tardo antico
Per i soldati la situazione era molto diversa dato che, fin da tempi più antichi, avevano maggior possibilità di disporre delle proprie finanze e del loro patrimonio per far testamento.
Il testamento, comunque, poteva anche esser revocato dalla stesura di un nuovo testamento. Chiunque aveva la possibilità di esser istituito erede, anche uno schiavo (ma solo a condizione che gli venisse concessa la libertà).
Se invece non vi era alcun erede, tutto il patrimonio del defunto andava usualmente ad aumentare il tesoro imperiale.
In alcuni casi leggi emanate tra il VI ed il VII secolo contemplavano eccezioni: le sostanze di un navicularius, ad esempio, andavano alla sua corporazione; quelle di un decurione alla curia cittadina. Lo stesso poteva valere per i soldati, i cui beni andavano al reparto in cui aveva prestato servizio.
Teodosio II, durante il V secolo, permise che i membri delle fabricae di armi, i cosiddetti fabricenses, avessero la facoltà di richiedere la restituzione dei beni dei loro membri deceduti, e alle chiese quelli del loro clero.
Costantino, inoltre, già aveva fatto cadere delle sanzioni che gravavano sui celibi in materia di eredità, poiché vedeva nel celibato una manifestazione delle virtù cristiane.
Di tutto ciò, però, abbiamo solo rare testimonianze di papiri egiziani, che ci mostrano all’atto pratico come venivano redatti i testamenti.
Pena di morte
In generale, l’aspettativa di vita nella tarda antichità non era molto elevata. Come già per i secoli precedenti, l’aspettativa media della vita femminile, per esempio, non era quasi mai superiore ai venticinque anni d’età.
A ciò, andrebbe anche aggiunte alcune particolari circostanze del periodo, come le carestie e le calamità naturali che colpirono soprattutto l’Africa e la penisola Italiana; la pesta giustinianea, e alcuni sconvolgimenti politici come la rivolta di Nika.
Inoltre, la pena di morte veniva comminata per numerosi crimini, anche se in realtà alcune categorie ne erano esenti, almeno che non si trattasse di reati considerati gravi come il tradimento o il parricidio.
Ma di fatto era tutto molto a discrezione del giudice.
Per le persone libere, la pena capitale era solitamente eseguita mediante la decapitazione con la spada, più raramente con altri sistemi.

La crocifissione, invece, era stata abolita già da Costantino. Mentre, l’esposizione alle fiere sembra essere già desueta. Anche se, nel 353, alcuni Isauri vennero dati in pasto alle belve nell’anfiteatro di Iconio, in Pisidia. Sorte analogo subì la condanna ai giochi gladiatori, quando questi vennero aboliti.
Costanzo II passò alla storia per esser stato il sovrano che istituì più processi “con maggiore accanimento di quanto stabilissero le leggi”, e dando incarichi a giudici noti per la loro crudeltà e severità.
Noto caso fu quello di Barbazione, un generale dell’esercito dell’imperatore, condannato a morte assieme alla moglie, a causa proprio dell’indiscrezione di lei.
Infatti, non appena il marito partì per una campagna militare, la moglie fece recapitare da un’ancella una lettera, in cui ella scrisse di non disprezzarla una volta che sarebbe salito al trono; insinuando quindi che il generale sarebbe succeduto a Costanzo II.
L’ancella, inoltre, mandò una copia della lettera ad un generale rivale, Arbizione, che si affrettò a riferire tutto al sovrano, che giudicò Barbazione colpevole per aver ricevuto la missiva, mentre la moglie fu giudicata colpevole di averla scritta.
Le condanne a morte furono molto frequenti anche sotto Valentiniano I, anche per futili motivi. Il sovrano estese poi l’obbligo della tortura anche per le cause di lesa maestà a coloro che ne erano tradizionalmente esenti. Inoltre, anche a Roma, i suoi sottoposti esercitarono la giustizia in modo del tutto feroce. Di ciò, ce ne dà testimonianza lo stesso Ammiano Marcellino, che addirittura parla di una “sospensione della giustizia”.
Neppure le donne sfuggirono alla giustizia imperiale con l’accusa di adulterio o di stupro. Come accade a due nobildonne, Charitas e Flaviana, la seconda venne addirittura condotta nuda al supplizio. Anche se, in seguito, il suo carnefice venne messo al rogo.
Anche nell’Impero d’Oriente, l’imperatore Valente fece tortura e strangolare uomini accusati di tradimento. Ma altri condannati subirono condanne alquanto bizzarre. Come il filosofo, Ceranio, che fu messo a morte per una frase scritta alla moglie, che la incitava a far qualcosa di importante.
Un altro caso, fu quello di un giovane, sorpreso a praticare un rituale per far cessare il mal di stomaco. Egli venne, infatti, visto alle terme avvicinare due dita prima la marmo e poi al petto.
Anche una guaritrice famosa, che guariva cantando, venne ugualmente uccisa.
Nei confronti degli usurpatori non vi era perdono alcuno e la condanna era ovviamente estesa anche ai loro seguaci.
Procopio, ribellatosi a Valente, venne dapprima decapitato e poi squartato; Magno Massimo fu abbandonato alla furia dei soldati di Teodosio. Mentre, Prisco Attalo, posto sul trono d’Occidente da Alarico, se la cavò con una mutilazione.
I funerali
I tradizionali riti romani di sepoltura, tramandati nel corso dei secoli, pretendevano la chiusura degli occhi del defunto, l’usanza di chiamarlo a più riprese tenendo le braccia rivolte verso l’alto ( alcuni sostengono anche per assicurarsi che non si trattasse di morte apparente), il lavaggio e l’unzione del corpo, la vestizione, l’incoronazione, l’introduzione di una moneta in bocca, ed infine l’esposizione della salma, attorniata da fiori e profumi per una durata variabile dai tre ai sette giorni.
Seguivano poi i funerali: inumazione o incinerazione, corteo con suonatori e prefiche, ed infine l’arrivo all’ultima dimora.
Dopo alcuni giorni, venivano eseguiti i riti di purificazione, ed il banchetto presso la tomba del defunto.
Il lutto seguiva precise regole comportamentali, e poteva durare dai dieci mesi ai tre anni.
Durante il periodo di lutto, solo l’imperatore poteva vestire di bianco, tutti gli altri, l’imperatrice compresa, dovevano indossare abiti neri. La stessa Anna Comnena ci narra che, alla morte del padre, si tolse il maphorion, l’abito purpureo e i calzari rossi, si tagliò i capelli, e indossò abiti scuri.
Nel terzo, nel nono, e nel quarantesimo giorno, dopo la sepoltura (giorni stabiliti in base al ciclo lunare) i parenti del defunto si ritrovavano attorno alla tomba per intonare dei lamenti.
La nuova religione non cambiò nulla, ma adattò alle proprie esigenze: la cremazione cadde in disuso, ma venne abolita la legge che vietava di seppellire i cadaveri nelle mura cittadine.
La legislazione tardo antica intervenì sporadicamente in materia: nel 363, Giuliano cercò di ristabilire l’obbligo di svolgerli soltanto nelle ore notturne, come nei tempi più antichi di Roma. Teodisio I ribadì il divieto di seppellire i cadaveri in città, anche presso le reliquie di santi (usanza questa tipicamente Orientale).

Era inoltre vietato porre oggetti preziosi nelle sepolture.
Giustino I e poi suo nipote, Giustiniano, nel 526 e nel 537, proibirono l’usanza per cui un creditore ritardava la sepoltura del cadavere del quale non era stato estinto il debito.
Ovviamente, solo i ricchi potevano permettersi funerali sontuosi, ma gli imperatori, Costantino, Anastasio I, e Giustiniano fecero delle leggi per l’organizzazione di funerali gratuiti. A Costantinopoli, vi era infatti un corpo di novecentocinquanta decani per provvedere ad ogni necessità. Costantino, inoltre, esonerò dal pagare le tasse coloro che fornissero un decano.
Altrove, come in età più antica, con molta probabilità sopravvivevano ancora i collegi funerari con lo scopo di dar degna sepoltura agli associati.
Nei cimiteri erano, infine, attivi i fossores o copiatae, che nel IV secolo ottennero un certo numero di immunità.
La morte in battaglia
Un autore romano scriveva: “La guerra è il pittore della morte”.
Questo passo è tratto da un genere letterario, forse ancora poco noto, della retorica militare.
In questi testi è affascinante notare che l’idea predominante della morte sia quella antica: della fama del miles nell’aldilà.
Nel VI secolo, un comandante militare affermava che non c’era nulla di più dolce che morire in battaglia.
Solo di rado compaiono reminiscenze cristiane in merito ad una vita ultraterrena.
Ancora nel IX sec. l’imperatore Leone il Saggio, nei suoi Taktika, assimila l’eroe che si distingue sul campo di battaglia al martire. Ma, per quanto ne sappiamo, in una sola occasione si fa menzione di celebrazioni liturgiche per i morti in guerra.
Inoltre, spettava al sovrano il compito di provvedere alle vedove.
Bibliografia (clicca i link qui sotto per acquistare la tua copia del libro)
G. Cavallo (a cura di) 1992, L’uomo bizantino
G. Ravegnani 2015, La vita quotidiana alla fine del mondo antico
T. Talbot Rice 1988, Everyday Life in Byzantium
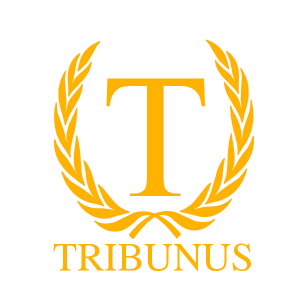


One thought on “La morte nel mondo tardo antico”