Leggi anche
La conquista della Magna Grecia. (1) Il conflitto con Taranto
La conquista della Magna Grecia. (2) La battaglia di Eraclea (280 a.C.)
Dopo la vittoria di Pirro nell’anno precedente, l’Urbe si adoperò alacremente per rinforzarsi in vista della ripresa del conflitto.
A comandare le legioni vennero chiamati i nuovi consoli, Publio Sulpicio e Publio Decio Mure.
Quest’ultimo era figlio di quel Decio Mure che si era sacrificato con il rito della devotio nella battaglia di Sentinum, o battaglia delle Nazioni (295 a.C.), e nipote di quel Decio Mure che, sempre tramite la devotio, aveva sacrificato sé stesso per la vittoria dell’esercito romano alla battaglia del Vesuvio (340 a.C.).
I due consoli, al comando di legioni e socii (per un totale complessivo variabile tra 40.000 e 70.000 uomini nelle fonti, con maggior probabilità verso la prima cifra), marciarono verso sud.
Pirro per canto suo non perse tempo. Con il suo esercito, rinforzato dai nuovi contingenti di alleati italici e magnogreci, risalì la costa adriatica con l’intento di penetrare nel Sannio e sottrarlo ai Romani.
Marciando l’uno contro l’altro, i due eserciti si incontrarono, nell’aprile del 279 a.C., lungo le rive del fiume Aufidus (Ofanto) nei pressi di Ausculum di Apulia (odierna Ascoli Satriano).
Come ad Eraclea, i Romani guadarono il fiume e attaccarono battaglia.

Ph. Martina Cammerata Photography
La battaglia di Ascoli Satriano
Rispetto alla battaglia di Eraclea, il re epirota disponeva di un esercito numericamente superiore a quello romano, infoltito da Lucani, Bruzi, e da contingenti di Sanniti che non accettavano il giogo romano. Lo accompagnavano anche gli inseparabili elefanti, diciannove e non venti come nel precedente scontro.
Tuttavia, tale vantaggio era reso meno efficace dal terreno.
I due consoli avevano scelto di scontrarsi con l’avversario in un teritorio boscoso, impervio, con alture e avvallamenti.
Uno scenario poco consono al dispiegamento efficace della falange ellenistica del re epirota e all’utilizzo dei suoi pachidermi.
Contro questi ultimi, inoltre, i Romani si erano ingegnati nel costruire degli speciali carri anti-elefante.
Pirro, col suo solito spirito, non si perse d’animo e decise di rispondere alle asperità del terreno con uno schieramento più mobile e imprevedibile, inframmezzando ai suoi falangiti reparti di italici.
Così descrive Dionigi di Alicarnasso lo schieramento del re epirota:
“[…] pose all’ala destra in prima fila la falange macedone e mise appresso i mercenari italici di Taranto, poi le truppe di Ambracia e la falange dei Tarantini con gli scudi bianchi, seguiti dagli alleati bruzi e lucani.
Al centro dello schieramento pose i Tesproti e i Caoni; a fianco di essi i mercenari etoli, acarmani e atamani, e per ultimi i Sanniti, a formare l’ala sinistra. Dispose la cavalleria dei Sanniti, dei Bruzi e dei Tessali all’ala destra, al pari di quella mercenaria dei Tarantini, e schierò sulla sinistra i cavalieri di Ambracia e quelli lucani e tarantini, nonché quelli mercenari greci, composti da atamani, etoli, macedoni e acarnani.
Le truppe armate alla leggera e gli elefanti li divise in due gruppi e li schierò dietro entrambe le ali, a una ragionevole distanza, dove c’era una modesta elevazione del terreno. Egli e la sua guardia composta da circa duecento cavalieri scelti stavano separati dallo schieramento, per essere pronti a soccorrere le truppe che dessero segni di sfinimento.”
Dal resoconto di Dionigi si evince chiaramente come Pirro voglia sfondare l’ala sinistra dell’esercito romano, rendendo di fatto la sua ala destra, con la falange, la parte più forte e solida del suo schieramento.

Ph. Martina Cammerata Photography
I Romani risposero con uno schieramento simile a quello del re.
I consoli mischiarono le legioni e i loro alleati (Campani, Sabini, Umbri, Volsci, Marrucini, Peligni, Ferentini) “perchè nessuna parte dello schieramento fosse debole”, come nota Dionigi di Alicarnasso.
La I legione era schierata sul fianco destro, affiancata dalla III e dalla IIII. La II legione, sull’ala sinistra, avrebbe dovuto subire in pieno l’impatto della falange di tipo macedone.
I consoli posizionarono poi la cavalleria a difesa dei fianchi e la fanteria leggera dei velites fuori dallo schieramento.
A completare le forze romane, una dotazione di 300 ingegnosi carri anti-elefante. Così li descrive Dionigi di Alicarnasso:
“Essi erano dotati o di pali trasversali, mobili, montati su travi ritte, che potevano essere fatti girare a comando nella direzione voluta e avevano alle estremità tridenti o spuntoni a forma di spada o falci tutte di ferro, oppure di ponticelli mobili che facevano calare dall’alto pesanti corvi.
A molti carri erano attaccati speciali bracci di fuoco, posti anteriormente a essi, con stoppa imbevuta di pece, con cui si recavano ferite alle loro proboscidi e ai musi. Sui carri a quattro ruote stavano molti fanti armati alla leggera, arcieri, lanciatori di pietre e di proiettili di ferro, e dietro di loro numerose altre truppe”.
Da tale descrizione, è curioso notare l’utilizzo sulla terraferma di un dispositivo che verrà usato con successo pochi decenni dopo contro le navi cartaginesi per arpionarle e agganciarle, durante la Prima Guerra Punica: il corvo.
Gli altri strumenti presenti sul carro erano atti a falciare le zampe degli elefanti o rendere difficile il loro incedere, mentre i bracci incendiari sarebbero serviti a terrorizzare e a ferire i pachidermi.
Arcieri e lanciatori avrebbero infine avuto la funzione di disturbare gli animali, ma soprattutto di ostacolare i tiratori presenti sulle torrette montate sul dorso degli elefanti stessi.
È difficile stabilire come effettivamente si sia svolto lo scontro, poiché le fonti che ce ne parlano (Plutarco, Dionigi di Alicarnasso, Cassio Dione) sono tra loro anche molto discordanti. Secondo Plutarco, la battaglia si sarebbe svolta addirittura su due giorni, quindi con due scontri consecutivi, prima che i contendenti lasciassero la zona, ma è l’unica fonte che riporta questo dato.
Si tenterà qui di ricostruire l’andamento della battaglia in modo realistico, incrociando i dati forniti dalle fonti.
La battaglia si accese con lo scontro tra le cavallerie avversarie, che si fronteggiarono senza che l’una riuscisse a prevalere sull’altra.
Le fanterie intanto erano giunte a scontrarsi tra loro.
Come ad Eraclea, i Romani cercavano di arrivare a combattere corpo a corpo, mentre Epiroti e Magnogreci caricavano, si ritiravano e poi ripartivano all’attacco.
Le ali destre, i due settori più forti di entrambi gli schieramenti, riuscirono a far ripiegare leggermente le corrispondenti ali sinistre avversarie, con una probabile rotazione dei due fronti – un meccanismo delle battaglie antiche che, del resto, descrive già Tucidide.
Tuttavia, a un certo punto la II legione riesce a respingere i falangiti epiroti, mentre contemporaneamente anche l’ala destra romana avanzava, creando una rottura della linea di combattimento, con l’apertura di ampi e pericolosi varchi.
Secondo Dionigi, a questo punto Pirro fece entrare in azione gli elefanti in un settore indebolito. L’autore non indica quale fosse questo settore, limitandosi a descrivere che i Lucani e Bruzi avevano ceduto al centro.
È ragionevole ipotizzare che tale settore fosse quindi relativo ai varchi aperti tra il centro e il fianco destro dello schieramento di Pirro.
Gli elefanti, passato lo schieramento spezzato caricarono i Romani.
Questi ultimi, ora preparati alla vista dei “buoi lucani”, lanciano nella mischia i loro speciali carri anti-elefante, provocando il panico nei pachidermi.
Tuttavia i guidatori riuscirono a bloccare la corsa disordinata degli animali a loro affidati, e i guerrieri dalle torrette iniziarono a scagliare proietti contro i carri. I fanti leggeri azzopparono i buoi che trainavano i carri e gli equipaggi di questi ultimi, esposti agli assalti nemici, fuggirono per trovare salvezza tra la fanteria dietro di loro, creando il caos.

Al centro, legionari della IIII legione tenevano impegnati e respingevano Lucani, Bruzi e Tarantini. Pirro mandò a loro rinforzo i cavalieri del suo contingente di guardia e dall’ala destra.
A questo punto, Pirro fu avvertito di un evento inatteso: il suo accampamento era sotto attacco.
Non si sa se per scelta tattica romana, o se per caso e per fortuna poiché giunto tardi sul campo di battaglia, un contingente di fanti e cavalieri Dauni non si unì ai combattimenti e si diresse verso il campo epirota, assaltandolo e facendo grasso bottino.
Pirro, una volta accortosi della minaccia, sganciò alcune truppe ed elefanti per contrastarla, ma una volta giunti all’accampamento non poterono che assistere alla ritirata dei Dauni sulle alture.
Queste stesse truppe ed elefanti si trovarono a scontrarsi con le legioni III e IIII, che prima si spinsero in avanti e poi si ritirarono a loro volta sulle alture, dove i pachidermi non potevano raggiungerli.
Come a Eraclea, solo il tramonto fermò la battaglia, e i rispettivi comandanti richiamarono le truppe. I Romani guadarono il fiume Aufidus e ritornarono al campo, non attaccato da Pirro.
Durante la battaglia, trovò la morte anche il console Publio Decio Mure. Secondo le fonti, anch’egli si sarebbe immolato per la vittoria con il rito della devotio, come il padre e il nonno prima di lui.
Il console si immolò agli dei Mani in cambio della vittoria dicendo, secondo la testimonianza di Cicerone nelle Tuscolanae Disputationes: “come un tempo mio padre, che più grande fece la nostra patria e la sua gloria, anche io per la vittoria la mia vita consacro e getto l’anima ai nemici”.
Difficile tuttavia stabilire se tale sacrificio abbia infine sortito l’effetto sperato.

L’esito della battaglia e l’abbandono di Pirro dell’Italia
Entrambi i contendenti rivendicarono la vittoria.
Il re dell’Epiro ebbe la vittoria tattica, seppur per una spanna, ma si vide del resto espugnato l’accampamento dagli alleati dei Romani. Questi ultimi, anche per questo motivo, si considerarono vincitori morali dello scontro. Tito Livio, tuttavia, parla realisticamente di un esito incerto.
Tra le fila dei Quiriti le perdite si contano in 6.000 unità contro le 3.550 tra gli Epiroti.
Tuttavia, le perdite epirote avrebbero pesato ben di più sulla bilancia del risultato, poiché Pirro si sarebbe trovato maggiormente in difficoltà nel rimpiazzare le perdite rispetto ai suoi avversari.
Secondo Plutarco, Pirro ebbe a dire una frase, purtroppo per lui, profetica: “Un’altra vittoria così sui Romani e sarò perduto”.
È del resto ben nota l’espressione “vittoria di Pirro”, a indicare un successo ottenuto a costi troppo elevati.
La battaglia di Ascoli Satriano, come del resto quella di Eraclea e molte altre successive tra i Romani e gli eserciti ellenistici, è chiaro come non sia stata una battaglia “pura” tra legione e falange.
Questo non solo per la presenza degli elefanti, ma anche perché entrambi gli schieramenti ricorrono a una serie di espedienti per sorprendere l’avversario: terreno non pianeggiante, carri accessoriati, reparti falangitici o legionari alternati a reparti di fanteria italica.

Nel complesso, l’esito della battaglia fu maggiormente favorevole ai Romani, se si considera che a livello strategico mantennero le loro posizioni e che poco dopo strinsero un’alleanza con la potente Cartagine.
Quest’ultima tornava in quel periodo a insidiare la libertà delle città siceliote, che chiamarono in loro soccorso proprio Pirro.
Il sovrano, forse anche in cerca di maggior fortuna, accettò la richiesta, ratificando un trattato di pace con i Romani (del tutto a loro vantaggio) per proteggersi le spalle.
Il re e avventuriero epirota uscì così temporaneamente dalla scena del territorio italico, che lo aveva visto affrontare tenacemente ma senza esito decisivo i barbari romani.
Gli scontri tra i Romani e il re dell’Epiro, tuttavia, erano ben lungi dall’essere terminati.
Leggi anche
La conquista della Magna Grecia. (4) La battaglia di Maleventum e la fine della guerra (275 a.C.)
Bibliografia
Fonti
Cicerone, Tuscolanae Disputationes
Cassio Dione, Storia romana
Diodoro Siculo, Biblioteca storica
Dionigi di Alicarnasso, Antichità romane
Orosio, Contro i pagani
Plutarco, Vite Parallele
Tito Livio, Ab Urbe Condita
Studi moderni
G. Brizzi 2002, Il guerriero, l’oplita, il legionario. Gli eserciti nel mondo classico
P. Connolly 1998, Greece and Rome at war
A. Frediani 2012, Le grandi battaglie tra Greci e Romani. Falange contro legione
L. Zerbini 2015, Le grandi battaglie dell’esercito romano
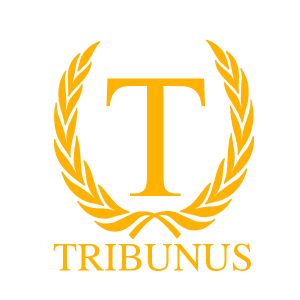


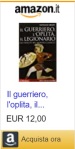
3 thoughts on “La conquista della Magna Grecia. (3) La battaglia di Ascoli Satriano (279 a.C.)”