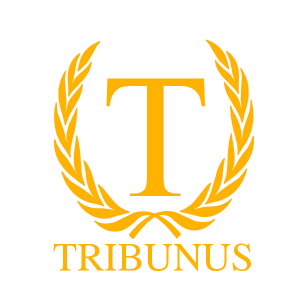Un oggetto può raccontare una storia?
L’elmo di Marco Patolcio è un caso in cui ciò accade.
Si tratta di un elmo di tipo Montefortino della seconda metà del III sec. a.C., da Pizzighettone (e oggi a Cremona, attualmente non esposto).
Sulla parte inferiore del paranuca, reca inciso il nome del proprietario.
L’iscrizione recita così:
𝘔. 𝘗𝘢𝘵𝘰𝘭𝘤𝘪𝘰 𝘈𝘳. 𝘭. 𝘱. 𝘝𝘐𝘐𝘐

Ci sono due scioglimenti possibili di questa iscrizione, che portano a due risultati molto differenti. Ma entrambi legati alla grande Storia.
In una delle due interpretazioni date, è stata sciolta come:
𝘔[𝘢𝘳𝘤𝘰] 𝘗𝘢𝘵𝘰𝘭𝘤𝘪𝘰 𝘈𝘳[𝘶𝘯𝘵𝘪𝘴] 𝘭[𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘰] 𝘱[𝘰𝘯𝘥𝘰] [𝘰𝘤𝘵𝘰]
In questo scioglimento, per prima cosa notiamo il cognomen 𝘗𝘢𝘵𝘰𝘭𝘤𝘪𝘰, di probabile origine etrusca, come confermerebbe anche il 𝘱𝘳𝘢𝘦𝘯𝘰𝘮𝘦𝘯 del patrono di Marco, 𝘈𝘳𝘳𝘶𝘯𝘴.
Il dettaglio più interessante è però la condizione sociale di Marco Patolcio, proprietario dell’elmo.
Secondo questa interpretazione dell’iscrizione, si tratterebbe infatti di un liberto (ovvero, uno schiavo liberato).
Ancora più precisamente, è stato ipotizzato che Marco Patolcio fosse uno di quei 𝘷𝘰𝘭𝘰𝘯𝘦𝘴 (volontari) levati dopo il disastro di Canne: schiavi giovani e di buona forma fisica ai quali, in cambio dell’arruolamento volontario, venivano offerte un’armatura pagata dall’erario e la libertà.
Ne vennero reclutati 8.000. Marco Patolcio era uno di loro?
Leggi anche Volones. Gli schiavi-soldato di Roma

Questo scioglimento è sicuramente il più affascinante e suggestivo, ed è impossibile non lasciarsi trasportare.
Tuttavia, vi è anche un’interpretazione certamente più solida, e che ci ricollega egualmente alla grande Storia.
Il secondo scioglimento proposto è infatti il seguente:
𝘔[𝘢𝘳𝘤𝘰] 𝘗𝘢𝘵𝘰𝘭𝘤𝘪𝘰 𝘢[𝘦]𝘳[𝘪𝘴] 𝘭[𝘪𝘣𝘳𝘢𝘦] [𝘱𝘰𝘯𝘥𝘰] [𝘰𝘤𝘵𝘰]
In questo caso, Marco Patolcio non ha nulla a che vedere con i 𝘷𝘰𝘭𝘰𝘯𝘦𝘴 della Seconda Guerra Punica. Si tratterebbe quindi di un soldato dell’esercito romano, forse un alleato, di origine etrusca.
Ciò che è indicato dopo il nome sarebbe semplicemente il peso dell’elmo.
Cosa ci faceva l’elmo di Marco Patolcio da quelle parti?
Visti anche altri reperti in zona, e vista l’area di ritrovamento, possiamo dire con una certa sicurezza che Marco Patolcio fu uno dei militari che partecipò alle operazioni del 222 a.C.
Sarebbe a dire, a quella campagna militare che sfociò nella famosa battaglia di Clastidium (relativamente vicina al luogo di ritrovamento).
Per la precisione, in diversi hanno identificato la città di Acerrae, assediata dai Romani prima della famosa battaglia, proprio nell’attuale Pizzighettone.

A volte un oggetto, attraverso la Storia di un individuo, riesce a darci un collegamento diretto con la “grande” Storia.
Ma non è finita qui, poiché, cosa sconosciuta ai più, a quanto pare nei pressi di Pizzighettone è stato rinvenuto un secondo elmo, del quale oggi è quasi persa la memoria.
Un elmo sconosciuto
Grazie alla segnalazione di Gianfranco Gambarelli sul nostro gruppo facebook, siamo venuti a conoscenza di un elmo fino ad oggi è rimasto sconosciuto ai più.
Si tratta di un secondo elmo Montefortino ritrovato nella zona dei combattimenti di Acerrae e Clastidium agli inizi del 1900 lungo la sponda dell’Adda, a lato della Torre de Guado presso Pizzighettone, durante uno scavo profondo circa 5 metri, destinato a mettere delle turbine per il mulino di proprietà dei Polenghi.
Questo elmo di tipo Montefortino fu pubblicato in due articoli, poco tempo dopo la scoperta, e fortunatamente fu disegnato.

L’elmo fu portato dai Polenghi nella loro sede londinese e non fu più reso, nonostante la richiesta della Soprintendenza. Ad oggi la sua attuale locazione è sconosciuta – e questa, considerando che il pezzo fa parte del nostro patrimonio storico e archeologico, è una situazione che andrebbe sicuramente corretta.
Anche questo elmo è stato certamente indossato da uno dei soldati romani o dei loro socii durante le operazioni militari tra Acerrae e Pizzighettone del 222 a.C.
Bibliografia essenziale
F. Coarelli 1976, Un elmo con iscrizione latina arcaica al Museo di Cremona, in “Publications de l’École Française de Rome”, 27, pp. 157-179